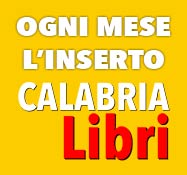di ANTONIETTA MARIA STRATI – Nonostante l’andamento positivo e la crescita del 3,0% rispetto al 2021, la Calabria rimane comunque indietro rispetto al Mezzogiorno e al resto d’Italia. Ciò significa che la strada è ancora lunga per tornare ai livelli pre-covid. Questi dati emergono dal Rapporto di Bankitalia presentati nei giorni scorsi a Catanzaro. La nostra regione, infatti, si è trovata in difficoltà a causa della forte incertezza legata alla guerra in Ucraina, della crescita dell’inflazione e del peggioramento delle condizioni di finanziamento, nonostante il quadro economico sia stato favorevole nella prima parte dell’anno.
L’incremento dei costi energetici e delle materie prime, che si è acuito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha progressivamente sospinto l’inflazione su livelli elevati nel confronto storico. Ne è conseguita una sensibile riduzione del potere di acquisto delle famiglie, specialmente quelle meno abbienti (più diffuse in Calabria rispetto al resto del Paese), che destinano una quota maggiore di consumi ad alcuni beni particolarmente interessati dagli aumenti (come elettricità, gas e prodotti alimentari). Nel contempo, l’incremento dei prezzi di vendita ha consentito una sostanziale tenuta dei risultati economici delle imprese.
E, proprio per quello che riguarda le imprese, l’andamento è stato migliore nei servizi, che hanno beneficiato del recupero nel comparto turistico e della ripresa dei consumi dopo l’emergenza pandemica, e nelle costruzioni. L’attività ha ristagnato nell’industria in senso stretto, che ha maggiormente risentito della crisi energetica; è risultata in calo nel settore agricolo, che sconta ancora l’elevato sbilanciamento del comparto verso alcune produzioni tradizionali.
In Calabria, infatti, il settore agricolo riveste un peso maggiore sull’economia nel confronto con la media italiana. Secondo i conti territoriali dell’Istat, esso rappresenta circa il 5 per cento del valore aggiunto, oltre il doppio del corrispondente dato nazionale; vi trova impiego il 13 per cento degli occupati, l’incidenza più alta tra le regioni italiane.
Nel complesso, gli investimenti sono cresciuti soprattutto tra quelli mirati a migliorare l’efficienza energetica o incrementare l’utilizzo e la produzione di energia rinnovabile, che potrebbero ulteriormente rafforzare la transizione già in atto verso tali fonti di energia.
«Nel 2019 – si legge nel rapporto – i consumi finali di energia della Calabria erano pari a circa 1,2 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per abitante, valore nettamente più basso rispetto alla media italiana (figura, pannello a). Il settore degli usi civili assorbiva il 46 per cento dei consumi finali, i trasporti il 41 e l’industria solo il 10 per cento; rispetto al dato italiano si osserva una minore quota del comparto industriale. Ciò riflette in parte il peso più contenuto del settore sul valore aggiunto regionale; inoltre, nell’industria l’intensità energetica Nel 2019 i consumi finali di energia della Calabria erano pari a circa 1,2 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per abitante, valore nettamente più basso rispetto alla media italiana (figura, pannello a). Il settore degli usi civili assorbiva il 46 per cento dei consumi finali, i trasporti il 41 e l’industria solo il 10 per cento; rispetto al dato italiano si osserva una minore quota del comparto industriale. Ciò riflette in parte il peso più contenuto del settore sul valore aggiunto regionale; inoltre, nell’industria l’intensità energetica».
Nonostante il forte incremento dei costi di produzione, la redditività delle imprese è stata sostenuta dal contemporaneo aumento dei prezzi di vendita e dalla modesta dinamica del costo del lavoro. La mortalità di impresa, sebbene in risalita, è rimasta inferiore a quella che si osservava prima della crisi Covid-19. La solvibilità delle aziende indebitate con il sistema bancario non ha mostrato ripercussioni significative; la liquidità pemane su livelli storicamente elevati, raggiunti grazie anche all’ampio ricorso delle imprese nel biennio 2020-21 alle misure pubbliche di sostegno introdotte durante la pandemia.
Bene sul lavoro. Nel 2022 il recupero dell’occupazione si è esteso anche alla componente del lavoro autonomo. L’andamento congiunturale ha favorito principalmente il settore dei servizi e quello delle costruzioni; quest’ultimo in prospettiva potrebbe essere ulteriormente rafforzato dall’attuazione delle opere previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il miglioramento osservato nell’ultimo biennio nei tassi di occupazione e disoccupazione è dovuto tuttavia anche alla contrazione della popolazione attiva, che riflette sia il mancato recupero nei tassi di partecipazione osservati prima della pandemia sia soprattutto il calo demografico in atto. Ciò rafforza dunque l’importanza di realizzare pienamente gli interventi di politica attiva previsti pure nel Pnrr, volti a favorire una maggiore e migliore partecipazione al mercato del lavoro.
Nonostante nello scorso anno l’espansione dell’occupazione dovrebbe aver favorito una lieve riduzione della disuguaglianza nella distribuzione del reddito da lavoro familiare equivalente, sospinta dalla diminuzione della quota di individui in famiglie senza occupati, «la Ccalabria continua a essere caratterizzata dalla presenza di un’ampia quota di nuclei in condizioni di disagio economico: secondo nostre stime sui dati dell’Indagine sulle spese delle famiglie dell’Istat, nel 2021 (ultimo dato disponibile) i nuclei familiari in povertà assoluta1 erano quasi l’11 per cento del totale, un valore superiore alla media nazionale (pari al 7,5 per cento). La presenza più diffusa in regione di famiglie economicamente svantaggiate può inoltre riflettersi in specifiche forme di povertà connesse alle difficoltà di accesso a determinati beni e servizi essenziali. In particolare, l’incremento dei prezzi di elettricità e gas potrebbe ulteriormente aggravare la condizione delle famiglie più vulnerabili, alimentando una maggiore diffusione della povertà energetica».
Ma che significa povertà energetica? Indica quando l’accesso ai servizi «energetici implica un impiego di risorse (in termini di spesa o reddito) superiore a quanto ritenuto socialmente accettabile oppure se non è in grado di sostenere l’acquisto di un paniere di beni e servizi energetici giudicati essenziali».
Nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021 (ultimo anno disponibile) la quota media dei nuclei familiari calabresi in PE è stata pari al 16,9 per cento (figura); il dato è nettamente superiore a quello italiano (8,5), principalmente per la componente LIHC – Low Income High Cost (ossia la quota di spesa per elettricità e riscaldamento particolarmente elevata) dell’indicatore.
Il reddito disponibile delle famiglie calabresi nel 2022 ha tratto vantaggio dai miglioramenti nei livelli occupazionali, ma il potere d’acquisto si è ridotto a causa della concomitante forte crescita dei prezzi, che ha anche frenato la ripresa dei consumi. L’aumento della spesa per l’acquisto di beni e servizi si è accompagnato a un incremento dei prestiti bancari. Le transazioni sul mercato immobiliare hanno mantenuto una crescita significativa, spinta ancora dalla ricomposizione della domanda verso abitazioni dotate di spazi esterni e situate al di fuori dei centri urbani.
Per quanto riguarda i consumi, in Calabria nel 2022 è proseguita la ripresa dei consumi, con una crescita del 4,9 per cento a valori costanti secondo le stime di Prometeia, lievemente inferiore ai dati nazionali.
«La dinamica dei consumi ha beneficiato del positivo andamento del mercato del lavoro, ma è stata frenata dai rincari dei prezzi e dal deterioramento del clima di fiducia – si legge nel rapporto – anche in connessione con l’incertezza derivante dalla guerra in Ucraina. Il recupero dei consumi rispetto ai valori pre-pandemia risulta così ancora incompleto, con un divario rispetto al 2019 che in regione si attesterebbe, in base alle stime disponibili, a 1,8 punti percentuali».
La spesa media delle famiglie calabresi nel 2021 (ultimo anno disponibile) è stata pari a 1.529 euro al mese, al netto dei fitti figurativi (1.844 euro nel Paese); la componente dei beni alimentari ha inciso per quasi un terzo, seguita dalle voci connesse con l’abitazione e le utenze e da quelle relative ai trasporti. Queste voci, più difficilmente comprimibili perché legate a bisogni primari, hanno un peso maggiore per le famiglie con minori livelli di spesa complessiva. Poiché gli aumenti dei prezzi hanno riguardato soprattutto tali voci, le famiglie meno abbienti sono risultate le più esposte alle pressioni inflazionistiche.
Aumenta, poi, la ricchezza delle famiglie calabresi: secondo le stime aggiornate al 2021 di Bankitalia, infatti, la ricchezza netta delle famiglie calabresi ammonta a circa 178 miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno precedente del 2,0 per cento (-2,4 per cento in termini reali). Il valore pro capite, pari a quasi 96 mila euro, era circa la metà di quello medio nazionale.
L’incremento della ricchezza netta nel 2021 è stato alimentato prevalentemente dalle attività finanziarie detenute dalle famiglie calabresi, che hanno continuato a crescere raggiungendo i 79 miliardi di euro (quasi 43 mila euro pro capite). Il valore delle attività reali è risultato in lieve aumento (0,6 per cento), in linea con il dato italiano. Nel complesso del periodo 2011-21 il valore corrente della ricchezza netta delle famiglie calabresi è cresciuto del 5,9 per cento; l’incremento, che si è intensificato a partire dal 2019, è stato comunque inferiore a quello medio nazionale (8,4 per cento).
Si è notevolmente ridotto, invece, l’investimento in titoli obbligazionari, anche se i primi dati disponibili sul 2022 sembrano evidenziare un’inversione di tendenza rispetto all’anno prima.
Preoccupa la natalità: «dopo il forte rimbalzo post-pandemico, nel 2022 il tasso di natalità netto (saldo fra iscrizioni e cessazioni in rapporto alle imprese attive)», viene evidenziato del Rapporto, «è sceso allo 0,8 per cento (dall’1,9 del 2021)». Una flessione che, tuttavia, si è registrata in tutto il Paese.
«L’andamento – si legge – ha riflesso sia la diminuzione del tasso di natalità, sia la crescita di quello di mortalità. Entrambi rimangono comunque su livelli più contenuti nel confronto con il periodo pre-pandemico; sulle minori cessazioni, oltre alla ripresa congiunturale, avrebbero continuato a incidere le misure di sostegno pubblico introdotte durante la pandemia e rimaste in vigore fino al primo semestre dello scorso anno.
Sanità. Nel 2022 si è registrato un sensibile aumento dei costi, «dopo la sostanziale stabilità osservata nell’anno precedente».
Particolarmente significativo l’incremento della spesa per l’acquisto di beni e servizi. Vi hanno contribuito in parte i rincari dei prezzi dei prodotti energetici e del gas, con un aumento della spesa per tali utenze di circa il 45 per cento nel 2022; per farvi fronte, a livello nazionale, sono state stanziate risorse aggiuntive, che per la Regione Calabria hanno più che compensato i maggiori oneri. La spesa in convenzione ha continuato a crescere nelle componenti collegate all’acquisto da privati di prestazioni ospedaliere e specialistiche; vi può aver influito l’attività di recupero delle liste di attesa.
Nonostante questo, il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nel 2022 si mantiene ancora inferiore ai valori antecedenti all’emergenza sanitaria. L’andamento del costo del personale (in aumento dell’1 per cento) è stato determinato principalmente dall’effetto monetario del rinnovo dei contratti della componente non dirigenziale, mentre l’organico ha mostrato ancora una lieve flessione. Tale dinamica ha contribuito ad accrescere il ricorso alle collaborazioni e consulenze sanitarie esterne, rafforzatesi già nel 2020 in risposta all’emergenza sanitaria.
Nel biennio 2021-22 l’incidenza di tale voce sul totale del costo del personale ha raggiunto il 4,4 per cento (era il 2,8 per cento nel biennio 2018-19). Il personale delle strutture pubbliche, nella componente sia stabile sia a termine, continua a mostrare una contrazione (-0,4 per cento), seppur inferiore rispetto a quella osservata nell’ultimo decennio (tav. a6.8). Secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato (RGS), a fine 2021 la dotazione di infermieri e di personale tecnico risultava in regione superiore ai valori antecedenti la pandemia; l’aumento ha però interessato essenzialmente i lavoratori con contratti a termine.
Il numero di medici ha continuato invece a ridursi, nonostante il significativo ricorso, anche in questo caso, a contratti temporanei. Per il personale medico si pone inoltre, in misura più forte rispetto ad altre f igure sanitarie, un problema di ricambio generazionale: a fine 2021 circa la metà dell’organico stabile operante presso strutture pubbliche aveva più di 60 anni di età (era solo il 13,6 per cento nel 2011; tav. a6.9 e fig. 6.5.b). I problemi legati all’invecchiamento del personale si presentano anche tra i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta: circa il 90 per cento di tali figure professionali si collocava nella fascia di anzianità di servizio più elevata (rispettivamente, più di 27 e 23 anni dalla laurea) e con un carico di pazienti per medico aumentato nel corso dell’ultimo decennio (nel 2021 il 24 per cento dei MMG e il 74 per cento dei pediatri presentava un numero di pazienti superiore alle soglie di legge).
Nonostante questo, è migliorato l’equilibrio economico-finanziario della sanità calabrese: sulla base dei dati di consuntivo 2021, è stato conseguito un avanzo di gestione pari a 145,6 milioni di euro, che ha consentito di dare piena copertura alle perdite pregresse al 31 dicembre 2020 (77,4 milioni di euro). (ams)