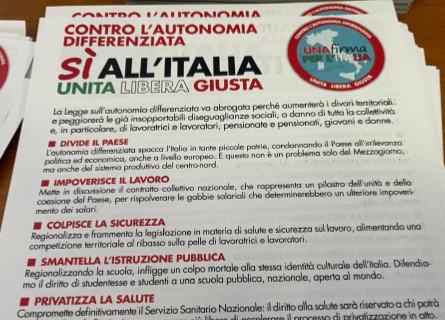di ANTONIETTA MARIA STRATI – A Reggio i minori e le loro famiglie invocano aiuto, Save the Children, il Tribunale per i Minorenni e il Centro Comunitario Agape rispondono. E lo fanno rinnovando un accordo che attiva ulteriori azioni concrete a tutela dei diritti dei minori e delle famiglie in difficoltà.
Un impegno, quello del Centro Comunitario Agape reggino – guidato da Mario Nasone – e del Tribunale per i Minorenni – guidato da Marcello D’Amico – continuo. A giugno, infatti, parlavano di «adolescenza e infanzia ferita» e chiedevano delle strategie d’intervento coinvolgendo le diverse istituzioni ed agenzie che si occupano dei minori per una riflessione a più voci.
Lo stesso Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Antonio Marziale, aveva ribadito la necessità di «fare «quadrato attorno ai bambini», e, oggi, lo si fa assieme a Save the Children, dove si chiede una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle Istituzioni e delle Associazioni.
E, con questo spirito, il Presidente del Tribunale per i minorenni, Marcello D’Amico, ha accolto la disponibilità di Save The Children e del Centro Comunitario Agape, di rinnovare un accordo di collaborazione che ha dato importanti risultati negli anni scorsi e che si ora si prefigge di attivare ulteriori azioni concrete a tutela dei diritti dei minori e delle famiglie in difficoltà. Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i minori a rischio e garantire loro un futuro, e Agape, con consolidata esperienza nell’ambito minorile, vogliono essere una risorsa per il Tribunale per i minorenni che continua ad essere un presidio fondamentale per la tutela degli interessi dei minori.
A raccontare l’importante lavoro che svolte il Tribunale, è stata Tiziana Catalano, psicologa e giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria: «diversi ruoli entrano in gioco perché si entra nella vita di persone, e sappiamo già che abbiamo bisogno di diverse competenze».
«Dobbiamo anche qui però – ha proseguito – dirci la verità: L’intervento dentro le mura di casa è il più doloroso, e sapete che accade? Che la società fa muro.Ci stiamo dimenticando del bambino che soffre, La società all’intervento come risponde? Ah ma lo stato è duro, è violento… ma com’è possibile sostenere questo? Quando la società dice così, dimentica il bambino. È proprio nel momento dell’intervento che la società deve insistere, non dimenticare. Al Tribunale quindi, si lavora in punta di piedi. Lo stato allora deve entrare, ma il villaggio deve essere solidale, non battersi il petto poi quando accade il fatto increscioso».
Il nuovo protocollo, curato dal giudice onorario Giuseppe Marino e alla cui ratifica erano presenti il magistrato minorile Paolo Ramondino, la rappresentante regionale dei programmi di Save the Children, Carla Sorgiovanni e la volontaria avvocata Elisabetta Martelli di Agape, che curerà con il Giudice onorario Marino il servizio di ascolto e coordinamento dell’intesa e che sarà operativo da settembre, prevede collaborazioni diverse.
Ad esempio la realizzazione, a cura di Save the Children e dei propri partner, nei territori di San luca e Locri, del progetto Buon Inizio, crescere in una comunità educante che si prende cura, già finanziato dall’impresa sociale Con I Bambini e rivolto alle famiglie, con la partecipazione a livello consultivo del Tribunale per i Minorenni, la realizzazione di momenti formativi e/o di approfondimento sulla protezione e ascolto dei Minori Stranieri Non Accompagnati (Msna rivolti al personale del Tm e a tutti gli attori – istituzionali e non – che a vario titolo si occupano della protezione dei minori migranti e operano nel territorio di competenza del Tribunale.
Inoltre, l’accordo include la realizzazione di momenti formativi e/o di approfondimento sulla legislazione in materia di responsabilità genitoriale e sulla valutazione della capacità genitoriale rivolti agli operatori dei progetti socio-educativi che Save the Children ed Agape promuovono sul territorio ed ai rappresentanti dei servizi sanitari servizi sanitari, sociali ed scolastici.
Il Centro Comunitario Agape garantirà, avvalendosi di volontari qualificati, l’apertura di un punto di ascolto c/o il Tribunale per i Minorenni per la consulenza alle persone in difficoltà ed ai cittadini che hanno esigenza di rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, lo stesso servizio sarà svolto presso la sede del Centro Comunitario Agape e sarà, inoltre, istituito un servizio telefonico attraverso il quale potranno essere raccolte le richieste di assistenza e di aiuto per le famiglie, gli insegnanti, le associazioni impegnate nella tutela dei minori.Verranno garantiti, su richiesta delle scuole interessate, incontri formativi e di consulenza con gli insegnanti e le famiglie c/o i presidi scolastici, e si collaborerà all’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni a sostegno dei minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.
Tra questi anche il consultorio per adolescenti Spazio Zeta, promosso all’interno del progetto Orientamento al futuro, lo Spazio genitori ed un servizio di orientamento legale a cura degli avvocati volontari della Marianella Garcia.
Secondo le prescrizioni dell’autorità giudiziaria minorile in sinergia con i giudici togati, onorari e con i curatori, il Centro Comunitario Agape collaborerà con proprio personale qualificato al monitoraggio dei minori del distretto allontanati dalla propria famiglia d’origine mettendo a disposizione risorse e servizi, curerà infine uno sportello informativo sull’affido etero familiare e iniziative di sensibilizzazione e formazione delle famiglie interessate d’intesa con il Tribunale.
Tutte azioni, queste, volte esclusivamente alla tutela dei minori e delle loro famiglie. Sicuramente il recente Piano di sostegno alle fragilità approvato dalla Giunta regionale – e plaudito dal Coordinamento regionale Affido e Adozione – è un primo passo per la vera tutela dei più piccoli, che «che necessitano di azioni di sostegno e di accompagnamento».
Ma non solo: è fondamentale, anche, «promuovere un ambiente educativo sicuro, rispettoso e inclusivo», come avevano ribadito i ragazzi e le ragazze del progetto Altavoce promosso da Save the Children e realizzato a Reggio dal Centro Comunitario Agape. Un intervento, il loro, a seguito dell’aggressione che ha coinvolto due studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, in cui hanno ribadito la necessità di «creare un ambiente scolastico e comunitario in cui ogni ragazzo possa sentirsi al sicuro, rispettato e sostenuto. La prepotenza e la violenza non hanno spazio nella nostra società, e dobbiamo lavorare insieme per prevenirli e affrontarli con determinazione e coraggio».
Ma non è solo la comunità a doversi impegnare. Ai primi di luglio, Lucia Lipari, del Centro Comunitario Agape e Claudio Venditti, del Forum Famiglia, si sono rivolti ai parlamentari affinché seguissero, con forte impegno, l’iter della riforma sui tribunali per i minorenni, «rappresentando a livello di Governo e del parlamento la situazione degli uffici giudiziari della regione coinvolti».
L’attenzione, in particolare, era da rivolgere al Tribunale per i Minorenni di Reggio e di Catanzaro, che operano in contesti dove la criminalità organizzata, le sacche di povertà e la debolezza del sistema del Welfare producono fenomeni gravi e diffusi di disagio sociale e di devianza, veri e propri avamposti di legalità che rischiano di essere privati della loro funzione di tutela dei minori per la mancanza di risorse a cui si unisce la complessità del nuovo quadro legislativo».
«L’attività svolta dal Tribunale per i Minorenni finora è stata cruciale – hanno evidenziato – per salvaguardare in particolare i diritti dei minori vittime di crimini domestici, inseriti in quei contesti in cui il paradigma offensivo si sviluppa quotidianamente. Si deve fare pertanto di tutto per scongiurare possibili disfunzioni nel sistema giudiziario».
«Per questo è necessario considerare che, oltre allo slittamento – hanno concluso – il Ministero della Giustizia provveda alla destinazione di fondi per l’assunzione di personale, anche di carattere amministrativo, che possa supportare la riforma che sin dalla sua stesura non ha ritenuto di prendere in considerazione le effettive realtà degli uffici giudiziari e dei territori». (ams)