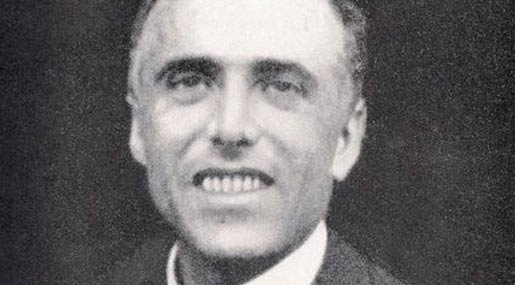Il 10 giugno 1924, Giacomo Matteotti, deputato e segretario del Partito socialista unitario, venne assassinato da un manipolo di fascisti. Lo ricorda il Comitato, composto da personalità della politica e della cultura catanzarese, istituito a Catanzaro dal sindaco Nicola Fiorita per le celebrazioni del centenario della morte del leader socialista.
Nei prossimi mesi, con il coinvolgimento delle scuole e delle istituzioni accademiche, si terranno alcune iniziative per ricordare una fase importante della nostra storia che ebbe nell’omicidio Matteotti uno dei momenti più significativi. L’obiettivo è quello di consolidare la consapevolezza sulle ragioni storiche della lotta per l’affermazione della libertà e della democrazia nel nostro Paese.
Con l’occasione, il Comitato intende anche offrire una riflessione sulle conseguenze del delitto Matteotti a Catanzaro e nella provincia.
Nell’aprile del 1924 si svolsero le elezioni politiche secondo le norme della legge Acerbo, sottosegretario alla presidenza del consiglio, voluta da Mussolini per garantire la vittoria del Partito Nazionale Fascista. Modificando il sistema proporzionale vigente dal 1919, la legge prevedeva un premio di maggioranza, pari a ben due terzi dei seggi, a beneficio del partito che avesse ottenuto almeno il 25 per cento dei voti (similmente alla proposta dell’attuale maggioranza di destra). Le liste che vennero proposte agli elettori furono dodici. In quella di maggioranza, ai fascisti furono aggregati i rappresentanti delle vecchie élite liberali.
Le opposizioni presentarono numerosi emendamenti per innalzare la percentuale di voti che avrebbe fruttato il premio di maggioranza, ma senza successo. In provincia di Catanzaro, i risultati elettorali mostrarono come nello schieramento di maggioranza i “trasformisti” liberali mantenessero un notevole consenso.
Ma anche nelle opposizioni vi furono deputati che dimostrarono di avere forti legami con gli elettori. In particolare, vanno ricordati i due che rappresentarono la città e la provincia di Catanzaro: Nicola Lombardi (democratico sociale) ed Enrico Molè (opposizione costituzionale).
Entrambi, assieme al socialista Enrico Mastracchi, non fecero mancare «una resistenza animatissima al fascismo» (per citare lo storico Antonio Carvello – La Calabria sotto il fascismo). Il consenso ottenuto, in diversi comuni superiore a quelle del “listone” di Mussolini, dimostrava la consistenza di un diffuso sentimento analogo nella società.
Il 30 maggio, Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze e i brogli elettorali e chiese l’annullamento delle elezioni. Il 10 giugno fu rapito e ucciso. Il suo cadavere, occultato nel bosco della Quartarella, presso Roma, fu ritrovato solo il 16 agosto. Intanto, l’opposizione antifascista era uscita dal Parlamento ritirandosi sull’Aventino. Quasi tutti i deputati calabresi parteciparono alla secessione aventiniana.
Nel fronte antifascista, insieme con tutti i rappresentanti dei partiti contrari, confluirono anche Nicola Lombardi ed Enrico Molè che in Calabria erano i più autorevoli esponenti dell’Unione Meridionale. L’azione degli aventiniani non ebbe successo e i fascisti superarono lo sbandamento seguito alla morte di Matteotti.
Nel 1925 ebbe inizio la dittatura di Mussolini che limitò la libertà di stampa e di opinione, diede luogo a perquisizioni personali e a confinamenti di esponenti a lui contrari. Le diversità politiche di opposizione furono cancellate: la secessione aventiniana si concluse Il 9 novembre 1926 allorché la Camera dei deputati deliberò la decadenza dei 123 deputati aventiniani.
Lombardi e Molè uscirono dalla scena politica parlamentare per intraprendere un’opposizione silenziosa svolta soprattutto nel contesto della massoneria alla quale entrambi appartenevano. Ripresero la loro attività dopo la liberazione. (Comitato di Catanzaro per il Centenario del delitto di Giacomo Matteotti)