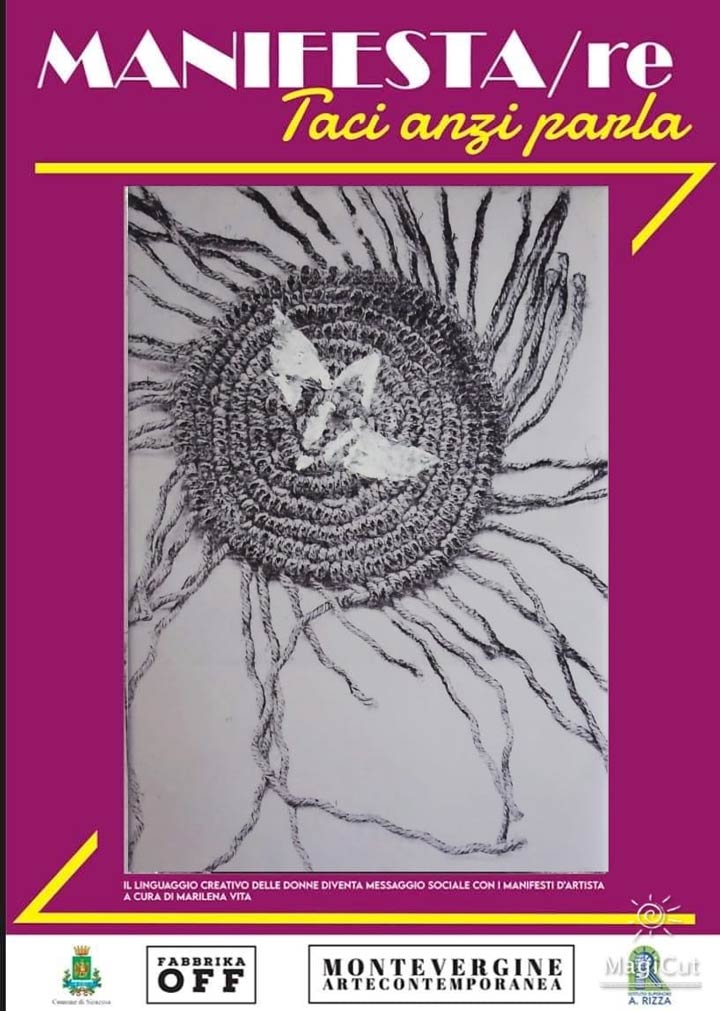di ANNA MARIA VENTURA – Nell’atmosfera suggestiva e pregna di storia e cultura della Biblioteca Gullo, a Macchia di Casali del Manco, continuano le “Conversazioni”, alla presenza di un pubblico colto ed interessato. Molto successo ha ottenuto la “Conversazione” della Prof.ssa Anna De Vincenti con il regista Nello Costabile, suo consorte, sul tema “La forza delle donne”. Le donne, oggetto della “conversazione” sono state: Hannah Arendt, Simone Weil e Rachel Bespaloff.
Tre donne, le quali, pur non frequentandosi e nemmeno in fondo conoscendosi veramente, hanno trovato ispirazione e conforto dalla lettura e rilettura del mondo greco delle origini e dell’Iliade in particolare. Come guardare, allora, a questo mondo che sembra perduto? Con uno sguardo né archeologico e né monumentale, secondo l’ottima relatrice, Prof. De Vincenti, ma critico, come ci suggerirebbe Nietzsche, che è lo stesso sguardo della Arendt, della Weil e della Bespaloff, che cercavano di orientarsi, in un momento storico, quello della Germania nazista e della persecuzione degli Ebrei, e le tre donne erano ebree, in cui sentivano in maniera tragicamente chiara quanto il mondo, il loro mondo, fosse completamente privo di orientamento. E se orientarsi significa cercare il proprio oriente, cioè il proprio “cominciamento”, allora diventa necessario per le tre donne rivolgere la mente e il cuore a quello che è il loro e anche il nostro oriente: la civiltà greca delle origini. Il “cominciamento” non può essere rivissuto, certo, ma può essere la linfa vitale a cui attingere. Cosa che possiamo e, forse, dobbiamo fare anche noi in questo tragico momento della nostra storia. Moderatrice dell’evento è stata la Direttrice della Biblioteca Gullo, dott.ssa Antonella Bongarzone, che ha impreziosito l’incontro con profonde riflessioni. A fare da controcanto alla relatrice è stata la voce del Maestro Nello Costabile, che ha dato ancor più prestigio al percorso culturale storico, filosofico e letterario lungo il quale Anna De Vincenti ha condotto gli ascoltatori. L’intervento di Anna De Vincenti è stato veramente ricco di cultura e di rara sensibilità. Il suo linguaggio raffinato e coinvolgente ha raggiuto ogni singolo rappresentante del pubblico.
Riportiamo spirito e contenuto dell’intervento attraverso le sue isposte alle domande che lei stessa pone nel corso della trattazione, intessendo una sorta di “dialogo” con il regista Costabile.
«Perché torniamo ogni volta al mondo greco?» si interroga la relatrice. La risposta le viene suggerita dal filosofo Giorgio Colli, che ha dedicato quasi tutta la sua vita allo studio della civiltà greca delle origini, Egli sostiene, afferma la De Vincenti, che l’immagine della Grecia che emerge dalla poesia omerica è quella di una civiltà all’interno della quale l’epica svolge un ruolo fondamentale nella formazione di una coscienza collettiva. Solo l’epica, infatti, ha saputo oltrepassare confini e particolarismi e fare breccia nel cuore del mondo ellenico; insomma, grazie all’Iliade e all’Odissea un’intera civiltà ha iniziato a leggere il proprio tempo con le categorie di quel mondo poetico. A partire dal VI secolo a.C. però, sempre secondo Colli, le pressioni esterne e l’allargamento degli scambi commerciali e culturali portano ad una serie di profondi cambiamenti: il risultato è la frammentazione della realtà e della coscienza in una molteplicità di diverse esperienze perennemente in competizione reciproca. Così si impone un progressivo senso d’incertezza intorno alla “via da prendere” e la verità si fa sfuggente. Quel mondo, allora, e quei valori vengono percepiti in qualche modo come perduti e proprio per questo, forse, devono essere conservati, come si conserva in uno scrigno una cosa molto preziosa, da non esibire ogni giorno, per non svilirla, per non renderla usuale e troppo consueta, ma a cui guardare in particolari momenti, quelli più difficili per se stessi e per l’umanità tutta, per attingerne coraggio e anche elementi di analisi.
Le nostre tre donne, continua la relatrice, hanno intrapreso un cammino di conoscenza e di svelatezza dell’essere. Infatti Rivelazione è la traduzione di alètheia (ἀλήθεια) che significa svelamento. Letteralmente è lo stato dell’essere evidente. Aletheia viene da lanthano, “coprire”, e, preceduto dall’alfa privativa, sta a designare ciò che si scopre. Infatti Heidegger, indagando il problema dell’essere, parla di «svelatezza» e conferma che la parola a-lètheia indica ciò che esce dall’oblio (lèthe) e si lascia vedere. Con l’etimologia di alètheia, Heidegger esprime l’esigenza di ritornare al rapporto originario di verità, ponendosi in attesa del momento in cui l’essere si lascia intravedere.
La Weil e la Bespaloff, ci dice la De Vincenti, in questo cammino dall’ente all’essere, incontrano l’Iliade. La trama dell’Iliade è semplice e luttuosa, dice appunto Aristotele nella Poetica, apprezzando la scelta geniale di Omero di non narrare l’intera guerra, ma solamente un suo episodio, anche se, come sappiamo, l’opera si arricchisce di scene apparentemente secondarie e tuttavia determinanti nella costruzione dei personaggi, del pathos che domina la narrazione, dell’etica e della metafisica che sovrintendono al suo universo. La De Vincenti asserisce che per Simone Weil è il poema della forza mentre per Rachel Bespalof è il poema della resistenza alla forza e se per la Weil l’eroe di riferimento è Achille, per la Bespaloff è Ettore, l’eroe della resistenza che si contrappone ad Achille, l’eroe della vendetta, quell’Ettore che possiede la disposizione e l’appetito della felicità, che ha un istante di esitazione prima di affrontare il tremendo nemico che lo ucciderà, ma poi pensa alla gloria e all’immortalità e decide di combattere: non può più evitare il destino di morte e sarà ben presto cadavere. In un libro molto bello di Nadia Fusini dal titolo Hannah e le altre, continua la De Vincenti, l’autrice Fusini con Dante canta Tre donne intorno al cor mi son venute, per parlare di Simone Weil, Rachel Bespaloff e Hannah Arendt.
Hanna Arendt nasce nel 1906 da famiglia ebrea ad Hannover, dopo gli studi uni-versitari è costretta ad abbandonare la Germania per motivi politici; si rifugia quindi in Francia nel 1933 e poi si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti nel 1941. Qui insegna in diverse università e, nell’agosto del 1944, fu invitata ai colloqui di Pontigny-en-Amerique dove tenne una conferenza sulla violenza a partire dal romanzo di Kafka Il Castello. Continua la sua attività di ricerca fino alla morte, che la coglie nel 1975 mentre si accinge a scrivere la terza e ultima parte della Vita della mente, l’ultimo suo capolavoro pubblicato postumo nel 1978. L’opera che la renderà famosa in tutto il mondo è il monumentale saggio del 1951 Le origini del totalitarismo, a cui nel 1958 seguirà La con¬dizione umana, titolo voluto dall’editore americano, mentre Hannah preferiva il titolo di Vita activa, conservato nella traduzione italiana del 1964. Di particolare rilevanza è inoltre il libro del 1963 intitolato La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, scritto in occasione del processo contro il criminale nazista Adolf Eichmann.
Hannah, che aveva preso parte al processo tenutosi a Gerusalemme come inviata speciale del «New Yorker», si convince che le ragioni profonde dei crimini nazisti risiedono non tanto nella cattiveria o nella mostruosità di alcuni carnefici, ma nell’assenza di pensiero in uomini del tutto normali, banali, che, se inseriti in una macchina infernale quale l’organizzazione nazista, diven¬tano capaci delle più disumane atrocità. Queste riflessioni, fatte da una donna ebrea, emancipata, laica e libera da ogni preconcetto, attirarono le critiche dello stesso mondo ebraico, che vedeva in esse una sottovalutazione del fenomeno nazista. Hannah ne Le origini del totalitarismo, spiega la De Vincenti, elabora uno schema generale, quasi un ideal-tipo, del regime totalitario, con esclusivo riferimento al nazismo e allo stalinismo, visti come due fenomeni riconducibili alla medesima idea di totalitarismo, essendo del tutto marginale l’interesse per altre forme di dittatura come, ad esempio, il fascismo e si propone di analizzare le cause e il funzionamento di questi regimi, considerati come una conseguenza tragica della società di massa, in cui gli uomini sono resi atomi, sradicati da ogni relazione interumana e privati dello stesso spazio pubblico in cui hanno senso l’azione e il discorso. Perché è fondamentale partire da questa considerazione? Si chiede la nostra relatrice. Perché gli esiti dell’ampia ricerca rinviano alla considerazione della scomparsa dall’orizzonte della modernità della dimensione genuinamente politica dell’uomo, quella che Hannah ritiene di scorgere nella polis dell’antica Grecia e che analizza in Vita activa: la con¬dizione umana, discutendone mirabilmente.
L’oggetto del saggio, come suggerisce il titolo voluto da Hannah, è la vita attiva, in quanto distinta dalla vita contemplativa, che sono i due momenti fondamentali, come avevano già affermato Platone e Aristotele, della condizione umana. Si noti, però, che Hannah, diversamente dai pensatori classici, parla di condizione e non di natura umana. La differenza non è di poco conto. La sola affermazione che possiamo fare circa la cosiddetta natura degli uomini, osserva Hannah, è che essi sono esseri condizionati, da cui, appunto, condizione umana. La «vita activa, cioè l’agire umano, si articola in tre forme fondamentali: l’attività lavorativa, che è propria dell’ animal laborans; l’operare, che è propria dell’ homo faber; l’agire, che è proprio dello zoon politikón. Delle tre manifestazioni della vita activa la più importante è la prassi politica, grazie alla quale gli uomini comunicano tra loro non attraverso gli oggetti, ma attraverso il linguaggio e le nobili gesta. E Hannah propone a questo punto alcune pagine molto belle e penetranti sulla civiltà dell’antica polis greca, che esaltava i valori dell’interazione comunicativa tra gli uomini liberi, veri e propri cittadini, in quanto protagonisti diretti della vita pubblica. Ancora prima della fondazione della polis, l’azione e il discorso erano considerati le attività più elevate dell’uomo. Come si evince dall’Iliade, la grandezza dell’Achille omerico può esser compresa solo se lo si concepisce come chi è autore di grandi imprese e pronuncia grandi parole (mégaloi lògoi), con cui rispondere ai colpi inferti dagli dèi. E la stessa cosa possiamo dire del vecchio Priamo che, quando parla, agisce perché discorso e azione sono equivalenti, dello stesso rango e dello stesso genere. Cosa significa questo? Si chiede ancora l’ottima relatrice. Significa che originariamente non solo l’azione più politica, in quanto rimane estranea alla sfera della violenza, si realizza nel discorso, ma anche, aspetto questo fon¬damentale, che trovare le parole opportune al momento opportuno, significa agire. Solo la mera violenza è muta, e per questa ragione soltanto essa non può mai essere grande. In questo senso la vera protagonista dell’Iliade è la forza, non gli uomini, davanti alla quale gli eroi e i grandi uomini, persino Priamo, restano muti, così come si resta muti davanti agli orrori del nazismo.
L’altra donna di cui parla Anna De Vincenti è Simone Weil. Figlia di ebrei benestanti e laici, nasce a Parigi nel 1909. Dopo un’infanzia, segnata da una salute precaria, in cui si appassiona alla letteratura, frequenta vari licei parigini, rivelando subito il suo carattere intransigente sul piano etico tanto che il suo preside la definisce in tono ironico imperativo categorico in gonnella. Segue, comunque, con successo i corsi di filosofia e nel 1930 consegue il diploma di studi superiori presso l’ École Normale, discutendo una tesi su Cartesio. A partire dagli anni Trenta insegna filosofia in vari licei e, contempora¬neamente, partecipa alle iniziative del sindacalismo di sinistra, da cui si lascia coinvol¬gere al punto che nel dicembre del 1930 si mette alla testa del movimento dei disoccu¬pati della cittadina francese di Le Puy, ove ella insegnava. Scrive vari articoli sui giornali sindacali, in cui analizza l’asservimento dell’uomo alle macchine e attacca l’apparato burocratico del Partito comunista, accusato di tradire gli interessi degli operai.
Questa attività a fianco dei poveri e degli operai le attira le critiche della stampa e dei genitori di alcune sue allieve, scandalizzati da un comportamento non consono alla dignità di docente. Dal 1934 al 1935 Simone fa l’esperienza più drammatica, che rappresenta la sperimentazione pratica della sua riflessione sul tema del lavoro: si congeda dall’insegnamento per trascorrere otto mesi come operaia presso varie industrie, tra cui la Renault, lavorando alle presse e alla fresa. Un sentimento di abbrutimento la invade.
Matura in questa fase l’idea sempre più precisa di quanto le contraddizioni sociali siano inestricabili e insolubili, anche dopo l’analisi del capitalismo fatta da Marx e dai teorici del comunismo. Perciò Simone abbandona gli ideali rivoluzionari, per concentrarsi sulla possibilità di un graduale miglioramento dell’organizzazione lavorativa: Un passaggio progressivo — ella dice — dalla subordina¬zione totale a un misto di subordinazione e collaborazione, rispetto al quale l’ideale sarebbe la cooperazione pura […] indipendentemente dai regimi politici. Resta sempre però centrale l’interesse per il lavoro manuale, tanto che definisce gli uomini lavoratori e creatori come i soli a essere uomini.
Nel 1935, durante un viaggio con i genitori in Portogallo, Simone assiste alla festa del patrono in un povero villaggio di pescatori: qui, mentre contempla estasiata le donne che in processione cantano inni antichi e compiono gesti rituali, ha inizio la sua svolta mistica: ho all’improvviso la certezza — così ella scrive — che il cristianesimo è per eccellenza la religione degli schiavi, che gli schiavi non possono non aderirvi, e io con loro. Sono anni di cupo pessimismo per la sua condizione esistenziale e per il momento storico: il nazismo e lo stalinismo dominano in Europa, mentre nella stessa America regnano incontrastati il capitalismo e la sua ferrea logica di asservimento della persona umana ai ritmi del lavoro produttivo.
Negli anni 1939-40 Simone si dedica a studiare filosoficamente il tema della violenza, partendo proprio dall’esperienza hitleriana e scrive il saggio critico L’Iliade, o il poema della forza, in cui analizza la forza come quel terribile potere che riesce a trasformare gli uomini in cose. Il vero eroe, il vero argomento, il centro dell’Iliade è la forza, ella afferma. La forza è ciò che rende chiunque le sia sottomesso una cosa. Quando sia esercitata fino in fondo, essa fa dell’uomo una cosa nel senso più letterale della parola, poiché lo trasforma in un cadavere. C’era qualcuno, e un attimo dopo non c’è nessuno. La storia greca aveva avuto inizio con un crimine atroce: Troia era stata distrutta e arsa; nella notte i guerrieri troiani erano stati massacrati, i bambini sfracellati contro le rocce; le donne prese prigioniere e portate in esilio. Allora, era nato un immenso rimorso, che aveva pesato su tutta la civiltà greca e, come suggerisce Simone, su tutta la storia che gli uomini fabbricarono dopo di allora. Le lacrime di Andromaca dopo la morte di Ettore sono le lacrime che piangiamo su noi stessi come attori e vittime della storia.
Simone trascorre l’ultimo periodo della sua vita in Inghilterra, ove muore di tubercolosi ad Ashford nel Kent il 17 agosto del 1943.
La terza donna di cui parla la De Vincenti è Rachel Bespaloff. Questa nasce in Bulgaria nel 1895 da una famiglia ebraica originaria dell’Ucraina: il padre, Daniel Pasmanik, è un medico con profondi interessi culturali mentre la madre, Debora Perlmutter, ha una formazione di ambito filosofico. In cerca di un ambiente più tollerante, la famiglia si trasferisce presto dalla Bulgaria in Svizzera e così Rachel cresce a Ginevra, compiendo fin da bambina studi musicali, diplomandosi in pianoforte e composizione al Conservatorio della città nel 1914; l’anno successivo insegna letteratura francese in un liceo. Nel 1919 si trasferisce a Parigi per occupare la cattedra di musica ed euritmica all’Opéra. Qui incontra nel 1922 Shraga Nissim Bespaloff, uomo d’affari socio del padre, che sposa e da cui ha la figlia Naomi. Nel 1930 i coniugi Bespaloff si trasferiscono in una piccola cittadina in un ambiente dove Rachel non si trova a proprio agio, rimpiangendo le frequentazioni e la vivacità culturale di Parigi, a quel tempo rifugio prediletto per quell’élite di esuli fuggiti dall’ex Impero russo. Rachel vive come una condanna l’allontanamento dallo stimolante milieu parigino, causa di sconforto e solitudine. Iniziano i sintomi del suo male di vivere: durante il 1938 trascorre un periodo in una clinica svizzera, a Montana, per ristabilirsi dai propri disturbi, nella stessa clinica dove nel 1937 era stata ricoverata Simone. Poi, altri spostamenti finché nell’estate del 1941, per sfuggire ai pericoli di incolumità nella Francia di Pétain, dove vigono le leggi razziali, lei e la famiglia abbandonano il paese trasferendosi negli Usa.
Negli Stati Uniti Rachel non riesce a radicarsi, ma porta a termine il suo saggio sull’Iliade, interpretando il poema omerico alla luce dei drammatici avvenimenti contemporanei. Nel 1943 insegna letteratura francese al College universitario di Mount Holyoke, ma la rendono infelice la superficialità della società americana e le penose condizioni della sua stessa famiglia: le difficoltà economiche, la malattia di cuore del signor Bespaloff e l’invalidità della madre. Anche se stimata da colleghi e allievi, Rachel si sente fuori posto e rimpiange Parigi e i vecchi amici. Muore suicida nel 1949, lasciandosi soffocare dal gas in casa sua. Lascia un messaggio: “Non cercate altre ragioni per il mio suicidio se non la mia estrema stanchezza”. Rachel compone un piccolo commento sull’Iliade, scaturito dalla lettura alla sua bambina delle gesta di Ettore, mentre Hitler varca les Champs Elysées. Il personaggio di riferimento è sicuramente Ettore, eroe umano, forse troppo umano. Fuori dalle porte Scee Ettore scorge Achille agitare la spada. Il guerriero più forte dei Troiani, il figlio più amato di Priamo, l’uomo simbolo di una città, trema, dimentica il suo coraggio e fugge. Fugge per ben tre volte attorno alla sacra Ilio e pensa: perché non garantire la pace promettendo ad Achille il ritorno di Elena e la spartizione di tutte le ricchezze di Troia? Già, perché non restituire Elena e smetterla lì? Perché a decidere non è lui e nemmeno Achille, a decidere è la guerra e lo spettacolo doveva andare avanti perché non è intorno alle mura di Troia ma nel recinto del cosmo e l’inseguimento del predatore e la fuga della preda devono continuare indefinitamente: tutti gli dèi li guardavano e dovevano godere dello spettacolo tragico.
E così Ettore, l’uomo che ha perduto tutto tranne se stesso, e per questo non s’inorgoglisce nel rispetto verso di sé né si umilia nel rispetto verso gli déi, alla fine va incontro a una morte certa nella consapevolezza di “abbandonare a una dolorosa distruzione tutto ciò che ama”, la moglie, il figlio, il padre e tutto il suo popolo, abbracciando “con un ultimo sguardo i veri beni della vita, all’improvviso esposti nella loro nudità di bersagli”. Ma, oltre che per Ettore, lo scavo psicologico e l’attenzione alla loro umanità e alle loro contraddizioni è per tutti i personaggi. Il contrasto che oppone Achille ad Ettore, pensa Rachel, va ben al di là della loro collocazione in schieramenti ostili e ben al di là dei loro ruoli e assurge a valore universale. Achille, uomo del continuo astio e del risentimento nonostante i ripetuti trionfi, che sta lì a rappresentare “il gioco della guerra, la gioia nel saccheggiare le città (…), il lustro dei trionfi inutili, delle imprese folli”, al punto da divenire “il solo personaggio dell’Iliade che finisce per essere odioso e atroce”. C’è, poi, Priamo, come asserisce la De Vincenti, il vecchio re, il quale rappresenta, immerso nella vertigine della fragilità umana, l’incarnazione della saggezza omerica. Ammirando il nemico che lo schiaccia, giustificando quella straniera la cui presenza è rovinosa per la città, il vecchio re assolve la vita nella sua totalità. Allora anche Achille, il vincitore, incontrando lo sguardo di Priamo, che non chiede altro che la restituzione del corpo morto del figlio, sembra ridestarsi da quella frenesia che fa di lui il meno libero tra gli esseri”, per ritornare per un attimo ad essere “un uomo carico d’infanzia e di morte”
In Omero non ci sono fazioni giuste o sbagliate, il male e il bene si intrecciano fino a confondersi nella bulimia della forza che tutto divora, pensa Rachel, eppure in tutto questo misero fango della vita c’è una dilaniante, infinita, tutta mortale bellezza, che sfocia nella più intoccabile tenerezza, di questi eroi umani che piangono eppure continuano a combattere. Insomma, secondo Rachel, contnua la relatrice, ciò che canta Omero è la resistenza alla forza, che diventa così il nucleo pulsante del poema. Nello scontro cosmico fra vita e morte, Omero canta l’uomo che non è solo una pedina, ma può avere l’ultima parola. L’importante è che sia quella giusta. Ed infatti, nel buio della notte dell’ultimo libro dell’Iliade, in una tenda dove si incontrano un padre senza figli e un figlio senza padre, una vittima e un omicida, un ragazzo e un vecchio, avviene l’incommensurabile, secondo Rachel, un incommensurabile che salva l’umanità dell’uomo: Achille prende la mano di Priamo e in quel silenzio rotto da un singhiozzo, si incrociano tutte le strade, finiscono tutte le storie. Ma prima che tutte le storie finiscano, prima che finisca la storia dell’occidente, là dove era iniziata, gli eroi piangono, i grandi uomini piangono, ridiventando soltanto uomini e piangendo ognuno i propri morti.
L’arabesco costruito da Anna De Vincenti per intrecciare i fili delle esistenze di queste donne fragili, ma al contempo gigantesche, sembra magico e fiabesco, eppure queste figure, attraverso il racconto rivelano il loro carisma e si delineano chiaramente come colonne del pensiero filosofico del Novecento, avendo lasciato tracce indelebili nella storia di questo secolo con il loro vissuto tribolato e sofferto. (amv)