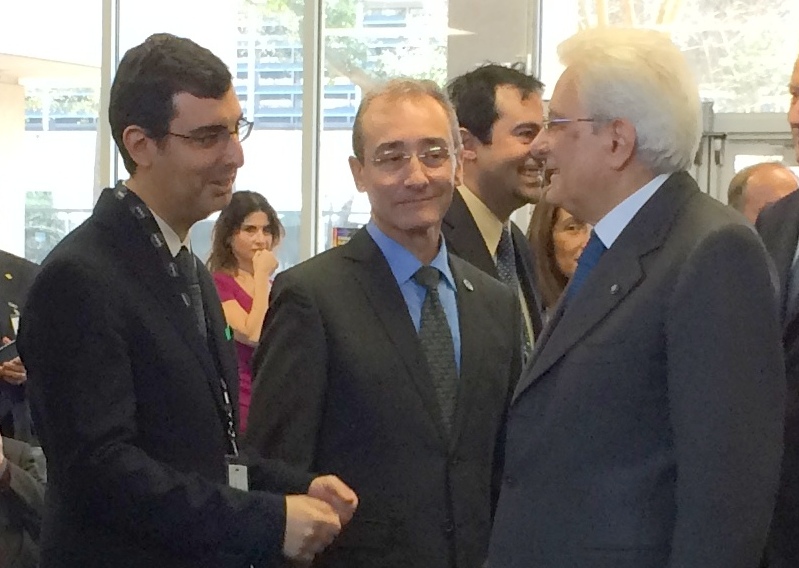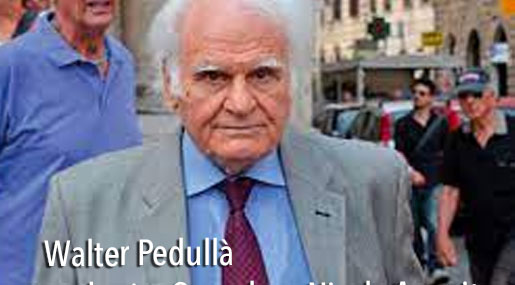di PINO NANO – Gianni Versace nasce a Reggio Calabria il 2 dicembre del 1946. Oggi avrebbe compiuto i suoi primi 75 anni. Se non fosse morto prematuramente, e fosse invece ancora tra di noi, non avremmo pensato due volte a dedicargli una delle nostre copertine. Ma l’altra sera Santo Strati mi sveglia e mi chiede un pezzo sul famoso stilista reggino. “Pino, ma perché non gli dedichiamo una delle nostre cover? È vero, lui non c’è più, ma la sua storia personale è ormai nei fatti il vero grande Molok della moda in tutto il mondo”.
Una favola moderna quella di Gianni Versace, e del suo impero, della sua infanzia e della sua famiglia, Gianni Santo e Donatella, testimoni del nostro tempo in tutti i sensi possibili e immaginabili, ma soprattutto testimoni autentici e dichiarati di una “Calabritudine” senza tempo e senza confini spaziali.
La loro è una favola bellissima, che alla fine si trasforma in tragedia, quasi una sceneggiatura cinematografica perfetta, attentamente studiata e costruita a tavolino per emozionare, coinvolgere, avvolgere, appassionare, e impazzire. Dentro questa storia c’è proprio tutto, la vita, la morte, la speranza di un mondo migliore, la costruzione di un progetto a prima vista impossibile, i sogni di intere generazioni di stilisti italiani, la crisi economica del Paese, la rinascita italiana, l’affermazione del made in Italy, e poi ancora la tradizione, il rispetto, l’onore, e l’innovazione di una terra come la nostra, la Calabria, dove tutto scorre molto lentamente e anni luce dagli algoritmi delle nano tecnologie. Illusioni, delusioni, malinconie, solitudini, lutti e resurrezioni, riscatti e rancori, rabbia e dolore, fatica e successo, amore e odio, amicizia e legami familiari indissolubili e atavici.
Gianni Versace, e la sua dinastia, è tutto questo, ed altro ancora.
L’uomo sembrava imbattibile, invincibile, inossidabile, quasi immortale, attorniato sempre da donne bellissime, top model che hanno segnato la vita di quasi un secolo, donne che lui guardava e trattava con un garbo estremo, quasi con soggezione, perché le considerava creature leggiadre e ideali per dare corpo vita ai suoi tessuti e ai suoi abiti di alta moda più belli. Donne da amare in passerella, donne da difendere, donne da rispettare, donne da preservare, donne del cuore. Era questa la sua filosofia più intima.
Donne come sinonimo di purezza e di bellezza insieme.
Gianni Versace dunque e le donne, un legame fortissimo, indissolubile, quasi magico, ma lo era perché tutta la sua vita in realtà era stata fortemente condizionata dalle tre “femmine” di casa Versace.
«Le mie tre donne di riferimento – diceva – erano mia madre, perché, al di là di qualche incomprensione legata al fatto che ogni madre è gelosa del proprio figlio, è stata la mia maestra. Mia madre mi ha aiutato a capire la moda. Poi mia sorella Donatella, perché mi dà un formidabile aiuto ad andare avanti, insieme a suo marito, Paul Beck. Infine, la loro bambina, Allegra. Allegra di nome e di fatto, perché in lei, nel suo senso estetico già sviluppatissimo, intravedo fin da ora il futuro».
Gianni e le donne di casa, dunque. Gianni e sua madre, soprattutto.
«Mia madre, nata a Reggio Calabria nel 1920 – racconta suo fratello Santo Versace in una intervista rilasciata nel 2006 a BusinessPeople – voleva fare il medico, ma nel 1930, dopo aver conseguito la licenza elementare, mio nonno le disse: «Cara Francesca, basta andare a scuola, perché nella scuola ci sono gli uomini e non è un luogo per bene. Adesso vai a imparare un mestiere». E lei si scelse quello di sarta, andando a bottega dalla “parigina”, che era una sarta che aveva lavorato a Parigi. Prima della Seconda guerra mondiale aprì il suo primo negozio. Gianni nacque nel 1946, io sono del ’44, Donatella del ’55, Tinuccia, morta a dieci anni, del ’43. Vivevamo in via dei Muratori a Reggio Calabria dove c’era il laboratorio della mamma. Sembra un destino segnato: se mio nonno avesse mandato mia madre a scuola forse Gianni non sarebbe diventato un genio della moda. Tutta colpa, anzi tutto merito del nonno! Gianni ha da sempre respirato quest’aria, mentre io respiravo quella di mio padre, commerciante e atleta di valore: ciclista e corridore con diverse vittorie all’attivo ma anche calciatore nella Reggina in serie C».
Era questo il mondo vero di Gianni Versace, il suo “piccolo mondo antico” che lui custodirà nel suo corpo per tutto il resto della sua vita.
«Nostra madre – ha ricordato la sorella Donatella a Silvia Nucini di Vanity Fair – era una donna che veniva da una famiglia povera. Aveva sposato un uomo ricco ma si è data talmente da fare che, grazie alla sua sartoria, è diventata più ricca e più importante di lui. Ogni matrimonio da Roma in giù era suo. Faceva l’abito alla sposa, e a tutte le altre invitate. Così, di matrimonio in matrimonio, ha iniziato ad aprire boutique, a girare per comprare i tessuti, è diventata anche amica di Karl Lagerfeld. Ricordo però che tutte le mamme dei miei amici li accompagnavano a scuola, e lei non c’era mai. Mi mancava. E anche se era una donna calabrese dell’inizio del Novecento, mi diceva sempre: non pensare al matrimonio. Perché se credi che un marito ti possa risolvere la vita, hai sbagliato tutto. Ma questo mi ha reso una donna caparbia, e ha reso forti tutti noi».
Ai suoi amici più cari Gianni non faceva altro che ripetere quello che poi diventerà il suo slogan più eccentrico e forse anche più romantico.
«Non sono mai caduto – diceva – Ho sempre volato».
E così poi è stato.
Ma aggiungeva: «Io non sono un disegnatore di moda. Sono soltanto un sarto. È questo il mio vero mestiere. I vestiti li so tagliare e cucire, cosa questa che non tutti però sanno fare».
È suo padre Antonio a regalargli il suo primo biglietto di ingresso a teatro della sua vita. Gianni è ancora un bambino, ma i colori del Cilea di Reggio Calabria colpiscono la sua immaginazione e la sua fantasia.
“Insieme padre e figlio – ricostruisce Esquire, la rivista maschile statunitense, fondata da David A. Smart e Arnold Gingrich nel 1933 – vanno a vedere Un ballo in maschera al Teatro Cilea, e sebbene Gianni sia ancora troppo piccolo per apprezzarne il contenuto, rimane affascinato dal contorno, dalle poltrone rosse, dalle signore eleganti, dai costumi colorati e maestosi. Tornato a casa raccoglie ritagli di tessuto e realizza dei burattini che fa muovere nel teatro della sua fantasia. Una immagine destinata a diventare realtà nel 1982 durante la stagione di balletto del Teatro alla Scala a Milano, quando accetta di disegnare i costumi per Josephslegende di Richard Strauss, la scenografia curata da Luigi Veronesi».
Reggio fortissimamente Reggio, insomma. Reggio Calabria, la città che Gianni Versace ha amato per tutto il resto della sua vita, nonostante poi si sia trasferito prima a Milano e poi in America, lui cittadino del mondo, ma apolide dovunque, con la sua Reggio nel cuore…
«Nel 1959-60 convinse mia madre a vendere anche gli abiti confezionati, oltre a quelli su misura. A neanche 14 anni – ricorda Santo – aveva già capito che si andava verso quel tipo di consumi. Insieme al talento di stilista dimostrava di avere anche il senso del mercato. Poco dopo la convinse ad aprire il negozio che c’èra in via Tommaso Gulli. Cominciò a farsi conoscere nell’ambiente. Un produttore di Martinafranca, in Puglia, capì subito che Gianni aveva talento e cominciò a commissionargli alcuni abiti. A quell’epoca i produttori erano pochi e si conoscevano tutti tra loro, perché era un’industria che stava nascendo. Negli anni ’60 Renato Balestra mandava a Gianni gli schizzi delle nuove collezioni e si confrontava con lui, un rapporto più di amicizia che di lavoro».
Il mondo “fantastico” di Gianni Versace era tutto quello che in realtà ruotava attorno a lui. Sembrava, il suo, un mondo quasi irraggiungibile, un satellite senza meta, che avevo perso la sua traiettoria inziale, un’isola abitata da vip, nomi altisonanti, grandi titoli sui giornali, mega show, rassegne internazionali di ogni tipo, concerti, interviste, teatri sempre pieni, eleganza, glamour, suggestioni mediatiche di ogni genere, e soprattutto grandi artisti estrosi e geniali eternamente per casa, come solo lui sapeva circondarsi.
La sua vita è stata attraversata e percorsa dai ritratti e dai manifesti dei grandi fotografi di tutti i tempi. Da Richard Avedon a Helmut Newton, da Irving Penn a Bruce Weber, da Herb Ritts a Doug Ordway, a Steven Meisel. Ma anche dalle top model più famose del mondo. Erano gli anni delle Fab Four, da Linda Evangelista a Naomi Campbell, da Claudia Schiffer a Christy Turlington, da Carla Bruni a Stephanie Seymour, da Cindy Crawford ad Helena Christensen, da Yasmeen Ghaur a Karen Mulder a Nadja Auermann.
«Quando hanno incominciato a posare per noi- raccontava spesso Gianni Versace – erano solo delle ragazzine. Christy Turlington, per esempio, una sera mi chiese, “Posso portare con me un’amica?”. Quell’amica era la giovanissima Naomi Campbell».
“L’imperatore dei sogni”, titolò il New Yorker pochi giorni dopo la sua morte.
«Gianni – ricorda suo fratello Santo – era davvero venerato come un imperatore. Ogni angolo del mondo lo ha pianto perché lui ha rivoluzionato il modo di pensare la moda. Era un artista a tutto tondo, e non solo uno stilista. Ha disegnato abiti per il teatro, per l’opera, era questa la sua autentica passione. E poi c’era la casa. La “home collection”, perché chi compra Versace ne deve restare avvolto. Ci si deve svegliare, deve viverne lo stile, lo deve respirare, ne deve acquisire il modo di pensare. Questo ci ripeteva Gianni continuamente. Mi diceva sempre anche sorridendo: “‘Non preoccuparti io continuerò a disegnare stracci”. Ma lui è sempre stato oltre, avanti. D’altronde è così che il suo talento ha trovato la luce: Era troppo luminoso per non venire fuori».
Successi dopo successi, trionfi dopo trionfi, Versace diventa un must in tutto il mondo. Dovunque e comunque si parla di lui e dei suoi colori sgargianti, delle sue figure mitologiche, delle sue meduse, dei suoi tessuti, dei suoi abiti d’alta moda, della sua raffinatissima e sfrontata genialità nel vestire sia donne che uomini.
A dicembre del 1997 viene inaugurata al Metropolitan Museum of Art di New York la “Grande Esposizione Gianni Versace” e fu un trionfo planetario. Nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo. L’esposizione, curata da Richard Martin, è la prima vera retrospettiva dedicata alla carriera dello stilista italiano dopo la sua morte, in mostra ci sono oltre cinquanta abiti tratti dalle sue collezioni più sofisticate e dalle sue continue collaborazioni teatrali.
Alla serata inaugurale – riferisce la stampa newyorkese – partecipano quasi tremila persone. Molti intervengono per salutare lo stilista calabrese e per tessere le sue lodi, indimenticabili e superbe le testimonianze di Anna Wintour, celeberrima direttrice di Vogue America, quella di Franca Sozzani direttrice di Vogue Italia, dello stilista Karl Lagerfeld, del grande coreografo francese Maurice Béjart, dei suoi amici cantanti Elton John, Sting e la moglie di Sting, Trudie Styler, di Cher, e infine delle sue top model preferite, Naomi Campbell, Eva Herzigova e Valeria Mazza.
L’anno successivo, nel giugno del 1998 viene inaugurata in Italia, a Como, la mostra “Gianni Versace, La reinvenzione della materia”, rassegna imponente sotto tutti i profili, divisa in due sedi separate, Villa Olmo e la Fondazione Ratti. Nella prima sede, a Villa Olmo, vengono esposti 120 abiti di tutta la carriera dello stilista, “illustrati” ed esposti – ricorda Santo Versace – in un percorso espositivo che raggruppava le creazioni in modo tematico e non cronologico.
Dall’altra parte invece, nella prestigiosissima Sede della Fondazione Ratti, vengono esposti, sempre in un percorso diviso per temi, alcuni dei materiali e dei tessuti che lo stilista utilizzava per le sue creazioni. Per la prima volta questi “materiali” che Gianni usava sin da ragazzo vengono qui affiancati dalle immagini delle campagne pubblicitarie e dei cataloghi degli abiti poi realizzati e che hanno raccontato il mito-Versace in tutti i continenti.
Ma fu tale il successo di questa nuova rassegna a lui dedicata che venne poi replicata nel 1999 al Museum of Modern Art di Miami, diventato oggi uno dei tempi sacri dell’arte moderna in tutto il mondo.
Sono i corsi e ricorsi della storia.
I suoi idoli preferiti erano i grandi maestri della pittura contemporanea, da Picasso a Kandinsky, ma anche della composizione e dell’allestimento, da Bob Wilson a Erté, da Pierre Le Pautre a Jean Bérain, la stessa architettura di Petitot lo avvolgeva e lo affascinava. Fino ai grandi maestri della canzone e della musica internazionale, da Elton John a Eric Clapton, a Sting.
L’amore tra Gianni Versace e Elton John, in particolare, amore che andava inteso esclusivamente come ammirazione viscerale dell’uno vero l’altro, nasce per caso, sull’orlo quasi di un incidente diplomatico che Elton John ricorda ogni qual volta gli si chiede di Versace.
«Una domenica a Woodside, depresso e strafatto, scrissi un brano strumentale che rifletteva il mio umore, cantandoci sopra un unico verso: ‘Life isn’t everything’, “La vita non è tutto”. L’indomani mattina seppi che un ragazzo di nome Guy Burchett che lavorava per la Rocket (la casa discografica di proprietà di Elton, ora chiusa) era morto in un incidente di moto quasi nello stesso momento in cui stavo scrivendo il brano. Decisi di intitolarlo “Song For Guy”, “Canzone per un ragazzo”. Non avevo mai composto nulla di simile: la mia casa discografica americana si rifiutò di pubblicarlo come singolo – mandandomi su tutte le furie –, ma in Europa fu una hit clamorosa. Anni dopo, quando conobbi Gianni Versace, mi disse che era la sua preferita fra le mie canzoni. Non faceva che ripetermi quanto la trovava straordinariamente coraggiosa. Secondo me esagerava un po’. Era insolita, certo, ma non l’avrei mai definita ‘coraggiosa’. Poco dopo scoprii invece che Gianni aveva capito male il titolo, “Song for a Gay”, “Canzone per un gay”».
Gli anni passano e Versace diventa sempre più famoso. Il suo nome diventa simbolo di una Italia che rinasce, e il suo marchio soprattutto diventa l’immagine forse più patinata ed esclusiva di un mondo, che è quello della moda italiana, e che grazie a lui non aveva eguali al mondo. Sono gli anni della Milano-bene, della Milano-internazionale, gli anni della grandi sfilate, dell’alta moda, del Made in Italy che conquista il mondo, gli anni in cui accanto a Gianni Versace crescono e diventano famosi ragazzi che come lui avevano incominciato dal basso, come Mariuccia Mandelli, Ottavio Missoni, Gianfranco Ferré, Laura Biagiotti, lo stesso grande grande Giorgio Armani.
È quello che Gianni Versace chiamava il “Nuovo Grande Rinascimento Italiano”.
Indimenticabile una foto in bianco e nero di Claudio Luffoli, per AP Foto, che ritrae un Gianni Versace ancora giovanissimo, la barba incolta e nerissima, insieme agli stilisti Giorgio Armani, Valentino, Krizia e Gianfranco Ferré ricevuti al Quirinale dal presidente Francesco Cossiga, che consegnò ad ognuno di loro i massimi riconoscimenti istituzionali per il loro lavoro e il loro ruolo nel mondo dell’alta moda. Era esattamente il 24 gennaio 1986.
Gianni for ever, Gianni meravigliosamente Gianni, Gianni eternamente Gianni. La commozione di Santo nel ricordare il fratello scomparso è palpabile e immediata quanto mai.
«Nel ’78, io e Gianni, fondiamo, con Claudio Luti, la Maison Gianni Versace. Il 28 marzo 1978, Gianni presenta la prima collezione firmata con il suo nome e nasce un’icona alla prima sfilata al palazzo della Permanente di Milano, e il logo del brand. Una Medusa, che attira immediatamente il pubblico di tutto il mondo. Così mi trasferisco definitivamente a Milano. Anni pazzeschi, di lavoro e di dedizione assoluta al servizio della estrosità e del genio che albergava nel corpo di Gianni. Pensa che aveva vinto anche il cancro nel ‘94, e si sentiva invincibile. Nei prossimi anni, mi ripeteva in continuazione, finalmente ci divertiamo. Oggi mi manca lui, mi manca il suo genio. Ma Gianni manca alla moda, all’Italia. Manca a tutto il mondo».
Non a caso forse, ormai famoso amato ammirato e invidiato in tutto il mondo Versace “si diverte” investendo il suo immenso patrimonio in opere d’arte, e il collezionismo – racconta in una lunga intervista allo scrittore Mario Biondi – diventa la sua vera mission.
«Quando si guadagna molto, è facile che venga la tentazione di comperare, che so, un aereo o una grande barca. Io i soldi per cose del genere non li ho, ma in ogni caso penso sia meglio circondarsi di oggetti belli. Sculture romane, vasi etruschi, mappamondi., opere di orientalisti, lucerne d’argento. Mi diverto di più. E ora sto chiudendo il ciclo. Sto arrivando all’arte moderna. Sto facendo una collezione di opere di arte contemporanea realizzate su commissione per la Fondazione Versace. Opere di Pistoletto, Palladino, Cucchi, Warhol, Boetti, Santomaso, Schifano, Clemente, Arnaldo Pomodoro. Ciascuno di essi ha fatto un’opera idealmente o materialmente collegata con il mio lavoro. Di Pomodoro, per esempio, ho comperato alcune sculture realizzate per un lavoro che abbiamo fatto insieme in teatro. Palladino ha dipinto due mie ideali camere, quella da giorno e quella da notte, con dentro tutti i simboli che sa che amo. E così via. Io sono convinto che stia per presentarsi un nuovo rinascimento italiano. E perché ciò avvenga, deve rinascere il mecenatismo. Chi ha, deve mettersi a disposizione dell’arte. Dal canto mio, faccio quello che posso».
Tutte le sue case, almeno le tre case principali che Gianni Versace aveva e dove viveva regolarmente, tra Milano e Miami, erano diventate suo malgrado un meraviglioso museo d’arte moderna, e quando Mario Biondi lo va a trovare e trova la sua casa di Milano invasa di mappamondi rimane di sasso, ma Gianni Versace sornione sorridente ed eclettico come tutti i sognatori del suo mondo, gli racconta la favola bellissima della sua vita.
«Il mappamondo? Mi aiuta a sognare. Forse perché il mondo è una cosa talmente bella che mi piacerebbe possederla tutta, dal punto di vista visivo. Vedere, viaggiare, se fossi nato nell’antichità, come mi ha detto una volta Maurice Béjart, avrei fatto parte “della banda di Ulisse”. Sempre in giro. “Tu sei un amico di Marco Polo”, mi ha detto un’altra volta».
E alla domanda di BusinessPeople, “Vi aspettavate questo enorme successo”, Santo Versace risponde ancora oggi alla sua maniera, con questo suo sorriso disarmante e questa sua semplicità che è rimasta tutta intera calabrese, e meridionale, nella sua accezione più bella.
«Nel 1976 un amico mi disse: “Ma non ti basta quello che tuo fratello fa per gli altri marchi? Perché volete crearne uno vostro, con tutti i rischi che comporta?”. Gli risposi: “Guarda, se tutto va bene faremo meglio di Yves Saint Laurent”. Dirlo nel 1976 era una follia. La coscienza del nostro valore e il grande lavoro ci hanno poi permesso di raggiungere questo risultato. Quando presentammo la collezione uomo 1978 dicemmo agli amici della Genny e della Callaghan che Gianni avrebbe continuato a lavorare per loro sulla donna, ma sull’uomo avremmo fatto da noi. L’anno prima solo sull’uomo avevamo fatturato 700 milioni di lire. Il successo fu tanto grande quanto inaspettato, Nessuno dei fornitori si era preparato a quadruplicare il fatturato, per cui ci trovammo in difficoltà. Vendemmo 2 miliardi e 800 milioni di lire la prima stagione, ma non essendo attrezzati per produrlo, consegnammo meno del 70% dell’ordinato. Poi la crescita è stata esponenziale».
Il 15 luglio 1997 i giornali e le TV di tutto il mondo aprono i titoli di testa con una notizia che riporta in primo piano il nome di Gianni Versace, e che nessuno avrebbe mai voluto leggere.
È una notizia di morte. Storia di una tragedia che si consuma a Miami proprio davanti alla villa in cui Gianni Versace viveva. Quella mattina di luglio, a Miami, Gianni Versace viene freddato sugli scalini della sua villa, “Casa Casuarina”, su Ocean Drive mentre stava tornando dal News Café a pochi isolati di distanza, dopo aver comprato i giornali del mattino. Ad ucciderlo, il giovane Andrew Cunanan, che nove giorni dopo l’omicidio viene ritrovato cadavere in una barca-abitazione a Indian Creek, “suicida” – dichiara la polizia americana- con lo stesso fucile con il quale aveva sparato a Versace.
«La sua morte – ricorda il fratello Santo in una intervista rilasciata nel 2013 all’ Huffington Post – è stata un danno incalcolabile non solo per l’azienda. Per Milano, dove Gianni era il numero uno indiscusso. Per l’Italia intera che ha perso uno dei suoi geni assoluti e ha dovuto rinunciare alla nascita del primo Polo del Lusso, al quale Gianni e io stavamo lavorando prima di quel tragico 15 luglio del 1997».
Commovente il ricordo che ne fa la sorella, Donatella, a Paola Pollo sull’ultimo numero di 7 del Corriere della Sera.
«Dopo 20 anni, ho imparato a convivere, in automatico, con la sua assenza. All’inizio è stata dura, durissima. Ho vissuto il mio dolore sotto gli occhi del mondo, ma con il passare del tempo, soprattutto con il lavoro, ce l’ho fatta. Con la Tribute Collection, la collezione a 20 anni dalla morte di Gianni Versace, nel settembre del 2017, è stata una catarsi. È stata la svolta, e sempre davanti a tutti. Quel giorno in un certo senso ho affrontato i miei demoni, la perdita di Gianni, ma anche le mie insicurezze che mi bloccavano nel continuo confronto con mio fratello».
Miami e l’America non hanno mai dimenticato quella tragedia.
Da allora ogni giorno, ancora oggi, a Miami centinaia di persone si fermano a fotografare l’ingresso del magnifico edificio che fu la casa di Versace, diventato dopo la sua morte un albergo extralusso.
Naturalmente, per Donatella e per suo fratello Santo – Santo sempre molto più riservato e più ritirato – “Gianni non è mai morto”.
«Lui è sempre nei miei pensieri- dice oggi Donatella –, in modo diverso rispetto ai primi anni, però c’è. Penso sempre a cosa direbbe sulle mie collezioni, il suo giudizio per me è importante, nonostante sia consapevole che non ci sia più. La gente non ha idea, se non quando lo prova, di cosa si attraversa quando perdi una persona che è la tua metà. Non sentivo più emozioni, nel bene e nel male, ero come intorpidita, ci sono voluti anni prima di ricrearle dentro di me, per vedere un orizzonte. E il dolore non passerà mai, ti adatti alla vita, ma quella cosa resterà per sempre».
Ma in realtà, anche per il resto del mondo, è come se Gianni non fosse mai morto.
Nel 1998 viene creato in suo onore il “Premio Versace Awards”, un premio in onore e alla memoria dello stilista, da assegnare durante i VH1 Fashion Awards alle personalità musicali “che avevano fatto dell’immagine e del costume una componente fondamentale della propria carriera”. E la prima grande artista mondiale a ricevere il premio è proprio Madonna.
Due anni più tardi la regina della serata dedicata a Gianni Versace sarà invece Jennifer Lopez. Un tripudio di personaggi, di eventi, di manifestazioni e di location che fanno rivivere Gianni Versace in ogni momento importante della storia della moda e dello stile di ogni Paese.
Ma è solo l’inizio di tutta una lunga serie di carovane e di rassegne che dopo la morte dello stilista lo ricordano e lo ripropongono come icona dell’eleganza italiana nella storia internazionale della moda.
Santo Versace lo ricorda ancora con immensa commozione, ma alla fine la storia di Gianni Versace è anche la storia personale di Santo suo fratello e di sua sorella Donatella, storia di una dinastia ormai che sembra destinata a segnare ancora per tantissimi anni la strada maestra della moda.
Nell’ottobre del 2002 il “Victoria and Albert Museum” di Londra gli dedica una delle rassegne più complete dedicate alla sua attività. Con il titolo “Versace at the V&A” vengono esposti centotrenta pezzi diversi, rarissimi, selezionati direttamente della collezione privata di Gianni Versace, tra cui alcuni degli abiti di gala indossati nel tempo da Madonna, Lady Diana, che Gianni Versace adorava quanto sua sorella Donatella, e poi Elton John e l’indimenticabile mise con le spille da balia indossata da Elizabeth Hurley, accompagnati da foto e bozzetti originali dello stilista.
A distanza di dieci anni dalla sua morte, il 15 luglio 2007, al Teatro alla Scala di Milano va in scena un balletto, ideato dall’amico Maurice Béjart, dal titolo Grazie Gianni con Amore, anche questo un trionfo di emozioni e di sentimenti che la stampa internazionale racconterà con toni enfatici e titoli di testa.
Un giorno Gianni capitò a Reggio Calabria e andò a cercare la sua vecchia sartoria al numero 13 di Via Tommaso Gulli, a due passi dal Duomo, e seduto davanti ad una tradizionale granita di caffè con panna si lasciò sfuggire quello che poi sarebbe diventato il suo vero testamento spirituale.
“Reggio è il regno dove è cominciata la favola della mia vita: la sartoria di mia madre, la boutique d’Alta Moda, il luogo dove, da piccolo, cominciai ad apprezzare l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide, e dove ho cominciato a respirare l’arte della Magna Grecia”.
Gianni Versace, For ever. We love you. ′