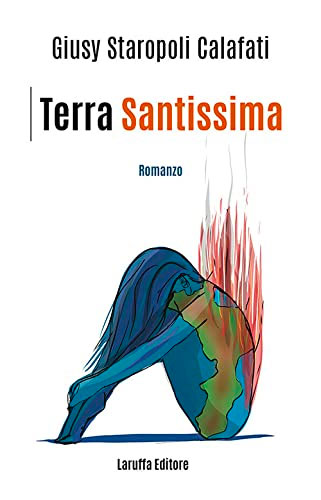di GIUSY STAROPOLI CALAFATI – Se dovessi scrivere alla Calabria, scriverei a me stessa, allora scrivo ai calabresi, e più precisamente a quelli che, con nomine amicali il più delle volte, siedono in Cittadella regionale o giù di lì.
Scrivo al Presidente della Regione Calabria e alla sua Giunta. Ai social media manager a cui è affidata la promozione regionale, e a quanti per “bontà dei cuori sciancati di questo e di quello”, si trovano nel circuito a correre la corsa per ogni genere di poltrona dirigenziale.
Cari voi tutti,
Vi scrivo perché se nascere in Calabria non si sceglie, essere calabresi sì. E la domanda che mi preme di porvi al quanto discreta, è la seguente: “Che genere di calabresi siete?”
Troppo qualunquemente viene trattata questa terra, ed io d’essere complice di questa ingratitudine, non me la sento. E mi dissocio. Sempre dalla parte della Calabria, ma non obbligatoriamente da quella dei calabresi (nemici dei calabresi stessi).
Quando venne istituito il concetto di “terra dei padri”, nel 2021, dentro di me profondamente radicato partire dal ’78, che è l’anno in cui nacqui, e testimoni ne sono i miei scritti e le mie battaglie, sentii fiorirmi il cuore di soldanella. All’epoca nessuno o pochi sapevano cosa fosse questo fiore. Ma io fiorivo dentro di me, perché la Calabria, che come aveva scritto Edward Lear ha già nel suo nome tanto di romantico, sembrava finalmente, voler riconquistare la propria identità perduta, riscoprendosi quel che è sempre stata: “terra dei padri”.
I risvolti, però, furono deludenti e tristi. La terra dei padri, venni a scoprire mano mano, era una mera propaganda commerciale che mai poteva coincidere con la verità umana e morale, civile e culturale della Calabria. Serviva un approfondimento che non c’era stato.
I 100 marcatori distintivi identitari con cui la terra dei padri intendeva proporsi al resto del mondo, facendo conoscere la propria storia, mancavano di tanti pezzi importanti. Dalla Certosa di Serra San Bruno, alla voce di Corrado Alvaro, ai giganti processionali Mata e Grifone, al Codice Romano Carratelli, e così via.
Mi chiesi cosa fosse l’identità per la politica regionale. Se questa fosse una pratica manuale corrispondente al sogno di un pugno di amici, o invece l’urgente necessità di un intero popolo volta al bene di un’intera regione. Perché vedete, il resto del mondo, e lo sappiamo bene tutti, non aspetta altro che farci il culo, e quando la mancanza non c’è se la inventa. Figurarsi a servirla su un piatto d’argento. E non c’è da andare molto lontano.
Tutti o quasi abbiamo avuto il piacere, io profonda ripugnanza, di leggere quanto nei giorni scorsi è stato pubblicato su “Visit Veneto”. Una campagna pubblicitaria che pur di sponsorizzare i siti veneti, denigra addirittura la Magna Grecia, definendola rovina. Una propaganda certamente ignobile, fatta sulla pelle della Calabria, ma ahimé, malgrado la ciotìa dei calabresi, la cui amministrazione si presenta sempre più approssimativa, improvvisata e qualunquista.
Alla Calabria Film Commission, mandiamo uno stilista. E sapete perché? Lui stesso lo dice: sono un grande amico del Presidente Occhiuto. Non avevamo per caso eccellenze a cui affidare la nostra cinematografia? Hai voglia se ne abbiamo. Forse ci rompevamo solo il cazzo ad andarle a cercare, individuarle, intercettarle. Ma che fesserie che andiamo facendo, e che perdite che facciamo gravare su noi stessi. Sul presente, sul futuro, sulla nostra storia. Sui nostri figli.
Per il 50° dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, viene presentato un logo che, per dirlo alla Sgarbi, fa davvero cagare. “Capre, capre, capre”. Non potevamo bandire un concorso internazionale, per la creazione di un logo unico, coinvolgendo grafici da tutto il mondo?
Ci sono errori che qui si compiono, e che si continuano ostinatamente a reiterare, e che la terra dei padri la trasformano in terra dei ciucci. E quelli come Zaia, lo sanno bene che a lavare la testa al ciuccio, si perdono acqua e sapone. E allora infilano il coltello nella piaga. Tanto sanno che noi sappiamo bene come fare a essere la piaga di noi stessi.
Ma quando arriverà mai il giorno della Calabria? Con tutto quanto abbiamo, ci saremmo dovuti mangiare il mondo. E invece rieccoci qui, ancora una volta, a fare i conti con l’incapacità, l’approssimazione, le offese gratuite… Davvero magre consolazioni per chi nella Calabria crede e investe tutto ciò che ha. L’anima, lo spirito, il lavoro, i risparmi, la storia, la famiglia, la terra. Tutto.
I padri dovevano essere l’esempio, la strada, il percorso, il viaggio. La rinascita, lo sviluppo, il riscatto. Con essi e per essi, bisognava partire dal concetto di Calabria come magnissima Colonna, dispensatrice di doti e di doni. Con uomini e donne a difesa della sua storia.
Una Calabria identitaria vera dunque, che sin dai nastri partenza abbia il vantaggio di appoggiarsi allo stato d’animo di chi la governa, e non sulle poltrone su cui ci si siede per governare.
Avete idea, Presidente, assessori, consiglieri, dirigenti, ecc. di quanto genio dispone questa terra?
Io sì! Non avrei redatto altrimenti il Manifesto inviato al Miur, e anche alla Regione (da cui attendo ancora risposta), affinchè gli autori calabresi vengano studiati nelle scuole italiane.
È tra quelle righe che chiedo venga istituita una legge regionale che preveda lo studio a scuola degli autori del ‘900; la prima Book Commission regionale, con la quale attraverso le opere dei nostri maggiori narratori vengano attuati progetti di sviluppo culturale e turistico; un ente regionale per la tutela della letteratura calabrese.
Guardiamo per un attimo appena ai nostri vicini. Ai dirimpettai siculi. La Sicilia, vanta addirittura di un assessorato all’identità regionale. Difende i suoi autori, li fa studiare, mantiene la sua lingua siciliana, la protegge e la conserva… A che serve parlare di terra dei padri, quando i padri non vengono fatti rivivere nella vita politica, sociale, civile e culturale del paese?
E qui la chiudo. Nei giorni scorsi, e quasi potrei gridare allo scandalo, l’assessore al Turismo della regione Calabria, pubblica sui suoi profili social, una poesia di Pablo Neruda, riportata su una sorta di carta intestata con il logo di Calabria Straordinaria, il nuovo progetto della Regione per lo sviluppo turistico del territorio.
Bene direte. Io invece dico male, anzi malissimo. E boccio, assumendomene tutte le responsabilità, l’assessore Fausto Orsomarso, pur riconoscendogli in campo, un impegno che in pochi hanno avuto prima di lui.
Ma davvero, caro assessore, serviva ricorrere a Neruda, che tra l’altro tanto amo come poeta, per raccontare una Calabria Straordinaria?
Una terra vera, reale, va raccontata con le sue voci. Per essere identitaria, la Calabria, va fatta parlare con le parole dei suoi artisti. Diceva Saverio Strati, che do per scontato sappiate tutti chi sia, in altro caso Google vi sarà d’aiuto: “Un popolo per capirsi deve conoscere i suoi artisti, altrimenti rimane indietro”. E allora, con tutto il rispetto per Pablo Neruda e la sua poesia, la Calabria Straordinaria, vi prego, raccontiamola così:
Un arancio
il tuo cuore
succo d’aurora,
rosa nel bicchiere
(Franco Costabile)
Noi non sappiamo
da che anima nata
e sei da per tutto indifesa.
Io mi diffondo
per obbliviosi porti
ed imparo di te
l’azzurro e il sereno.
(Lorenzo Calogero)
Alla domanda: Chi siete? I nostri figli, ricchi di sapere e di conoscenza, con orgoglio, già oggi, dovranno poter rispondere: “La regione più bella del mondo”. Sempre più straordinaria, e meno sbronza. (gsc)