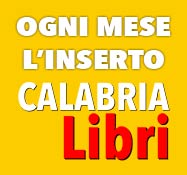di FRANCESCO AIELLO – Osservare le dinamiche del mercato del lavoro è come comprendere l’evoluzione di un sistema economico. Analizzare la forza lavoro, chi trova occupazione e chi ne resta escluso significa cogliere aspetti cruciali della crescita economica, della coesione sociale e delle aspettative individuali. Nel caso della Calabria, questo esercizio assume un valore ancora più rilevante. Qui, più che altrove, le dinamiche occupazionali hanno riflesso – e in parte alimentato – una stagnazione di lungo periodo. Tra il 1995 e il 2024, mentre l’Italia ha vissuto fasi alterne, con segnali di crescita e di adattamento, i dati della Calabria raccontano una storia di distacco strutturale rispetto al resto del Paese, che non si è colmato nemmeno nelle fasi espansive.
Sebbene molti dei contenuti illustrati in questa nota possano risultare familiari, soprattutto a chi studia o insegna materie economiche, l’osservazione di un periodo esteso consente di cogliere con maggiore chiarezza la direzione delle trasformazioni avvenute. Il confronto trentennale tra Calabria, Mezzogiorno, Centro-Nord e Italia aiuta a leggere in profondità le traiettorie divergenti che hanno caratterizzato il mercato del lavoro regionale.
Tre sono le domande guida: la Calabria ha recuperato o perso terreno? Ha seguito un’evoluzione simile o divergente rispetto al resto del Paese? E soprattutto: cosa ci dicono questi dati sulla possibilità, oggi, di immaginare uno sviluppo diverso?
La dinamica della popolazione in età lavorativa (15-64 anni)
Nel trentennio 1995–2024, la Calabria ha sperimentato una progressiva contrazione della popolazione in età lavorativa (15–64 anni), passando da oltre 1,296 milioni di individui nel 1995 a circa 1,163 milioni nel 2024. Si tratta di una perdita netta di circa 133.000 persone, pari a un calo di oltre il 10%, il più marcato tra tutte le macroaree italiane. Se confrontata con il resto del paese, in Calabria queste dinamiche sono particolarmente severe. Nel 2024 la popolazione in età lavorativa è diminuita del 4,2% in Italia, dell’1,6% nel Centro-Nord, ma dell’8,8% nel Mezzogiorno.
La Calabria, con il suo -10,3%, si conferma come una delle regioni in cui la fragilità demografica si è espressa in modo più netto. Questo dato riflette una duplice fragilità: la prima è legata a dinamiche demografiche (progressivo invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite), mentre la seconda è associata ai saldi migratori negativi, in particolare di giovani e adulti in età da lavoro. Questa combinazione ha ridotto non solo il numero di potenziali partecipanti al mercato del lavoro, ma anche la qualità complessiva della forza lavoro, svuotando la regione di competenze e capitale umano.
La popolazione in età lavorativa comprende i residenti attivi, ossia la forza lavoro (occupati e disoccupati in cerca di lavoro), e gli inattivi, cioè coloro che non lavorano né cercano attivamente un impiego. Nel 2024, la forza lavoro calabrese ammonta a 601.755 persone, mentre gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono 561.170.
In altri termini, nel 2024 circa il 48% della popolazione calabrese in età da lavoro risulta inattiva. Si tratta di una quota molto elevata per un contesto regionale inserito in un’economia avanzata, e che riflette una vulnerabilità del modello economico. Il fenomeno, però, non è nuovo né transitorio. Già nel 1995, la forza lavoro regionale era pari a 656.905 unità, mentre gli inattivi erano 639.138. Su una popolazione complessiva in età lavorativa di circa 1.296.000 persone, quasi il 49,3% risultava inattivo. Si tratta di valori medi che caratterizzano l’intero periodo osservato, anche se non sono mancati momenti di parziale riequilibrio: tra il 1997 e il 2002 si registra una crescita della forza lavoro e una riduzione degli inattivi, mentre dal 2003 in poi le due dinamiche si invertono. Il divario si amplia negli anni successivi, fino a culminare con la crisi del 2008, quando il numero degli inattivi supera stabilmente quello della forza lavoro.
La persistenza di questa dinamica nel corso di trent’anni indica un problema radicato e sistemico, che limita la capacità della Calabria di generare crescita economica, alimenta la dipendenza da trasferimenti pubblici e ostacola la sostenibilità delle finanze pubbliche locali e nazionali. La presenza di centinaia di migliaia di persone in età attiva ma completamente disimpegnate dalla partecipazione economica, rappresenta uno dei principali vincoli allo sviluppo della regione. Per comprendere meglio l’effettiva mobilitazione del capitale umano disponibile, è utile analizzare l’andamento della partecipazione al mercato del lavoro, ovvero il grado di attivazione della popolazione in età lavorativa.
Tendenze del tasso di attività (1995–2024)
L’indicatore che meglio sintetizza la “vitalità” del mercato del lavoro è il tasso di attività. Il tasso di attività della Calabria – ovvero il rapporto tra forza lavoro e popolazione in età 15–64 anni – si è mantenuto su livelli cronicamente inferiori rispetto alla media nazionale, senza alcun segnale di convergenza. Nel 1995 il dato regionale era pari al 50,7%, mentre a livello italiano si registrava un tasso attorno al 59%. Ventinove anni dopo, nel 2024, il tasso di attività in Calabra è rimasto pressoché immobile, oscillando intorno al 51,7%, a fronte di un aumento tendenziale del dato nazionale che ha superato il 66% nei migliori anni pre-pandemici, per poi stabilizzarsi su valori comunque più elevati.
L’andamento del tasso calabrese evidenzia una stabilità su livelli bassi, con variazioni cicliche contenute e senza rimbalzi significativi neanche nelle fasi espansive del ciclo economico nazionale. A differenza di altre regioni meridionali che hanno conosciuto una moderata crescita della partecipazione dal 2015 in poi, la Calabria ha mantenuto un andamento piatto, con il tasso di attività che raramente ha superato il 53% (massimo toccato nel 1999). La situazione è progressivamente deteriorata nel decennio successivo alla crisi del 2008, con un calo più marcato della forza lavoro a partire dal 2017: tra il 2010 e il 2024, la forza lavoro è calata in valore assoluto, passando da 620.000 a circa 602.000 persone, anche per effetto della riduzione della popolazione residente in età lavorativa.
È evidente il dualismo dell’economia del Paese: l’area centro-settentrionale registra una dinamica crescente del tasso di attività, che nel 2024 si attesta al 72%, e il Mezzogiorno d’Italia, al contrario, mostra timidi segnali di crescita in ristrette fasi temporali, ma che nel complesso registra un ampliamento significativo del divario con resto del paese: nel 1995 la differenza del tasso di attività tra le due macro-regioni era di 9.6 punti percentuali, passati addirittura a 15.9 nel 2024).
Il confronto con il Centro-Nord – l’area più dinamica dell’economia italiana – conferma il ritardo strutturale della Calabria: nel 2024 il divario nel tasso di attività è di ben 21 punti percentuali. Va, inoltre, sottolineato che la Calabria presenta un tasso di attività inferiore anche rispetto alla media delle altre regioni meridionali.
Questi dati rivelano una debolezza strutturale profonda: in Calabria, una quota consistenze della popolazione in età lavorativa si è progressivamente allontanata dal mercato del lavoro. Si tratta di un fenomeno radicato, che riflette disillusione, scarsità di opportunità e disallineamento tra offerta e domanda di competenze.
Nel confronto con il Centro-Nord, la distanza appare ancora più netta: mentre in quell’area la partecipazione al mercato del lavoro è aumentata, in Calabria la struttura si è cristallizzata in un modello a bassa partecipazione. È una situazione che indebolisce gravemente il potenziale di crescita della regione.
Per approfondire l’andamento della partecipazione, conviene ora esaminare come si è composta nel tempo la forza lavoro, osservando il peso relativo di occupati e disoccupati. Iniziando dal dato complessivo sulla forza lavoro, possiamo osservare le principali tendenze di lungo periodo che hanno caratterizzato la partecipazione economica in Calabria.
Andamento della forza lavoro nel periodo 1995-2024
La forza lavoro in Calabria ha seguito un trend decrescente. Nel 1995, le persone in età 15–64 anni attive nel mercato del lavoro erano circa 657 mila, scese a 602 mila nel 2024. Un calo strutturale dell’offerta di lavoro, già delineato nei paragrafi precedenti, conferma l’erosione della base attiva su cui si regge il sistema economico regionale. Dopo una temporanea espansione nei primi anni 2000, la forza lavoro ha intrapreso un percorso di regolare declino, che riflette la debolezza endemica del sistema economico regionale, incapace di generare opportunità tali da trattenere o attrarre risorse umane.
Nel confronto con le altre aree del Paese, la traiettoria calabrese appare ancora più anomala. Dal 1995 al 2024 la forza lavoro in Italia è cresciuta complessivamente di circa il 10%, con una dinamica più marcata nel Centro-Nord (+13%), più contenuta nel Mezzogiorno (+3%) e nettamente negativa in Calabria (–8%).
Anche nei momenti di ripresa a livello nazionale, la regione evidenzia segnali di debolezza. A partire dal 2004, anno in cui la Calabria registra il suo massimo storico nella partecipazione al mercato del lavoro (circa 700 mila attivi), inizia una fase discendente che si intensifica dopo il 2008. Con una dinamica divergente sia rispetto al Nord che alle medie meridionali, in Calabria il trend si inverte strutturalmente. Ne risultano una perdita secca di capitale umano e una riduzione della base attiva su cui fondare la crescita.
Questi dati indicano che la regione non solo crea meno occupazione, ma coinvolge sempre meno persone nei processi economici e produttivi. Si tratta di un segnale allarmante, perché la riduzione della forza lavoro non è solo effetto dell’invecchiamento demografico o delle dinamiche migratorie, ma è soprattutto il sintomo di un disallineamento profondo tra offerta e domanda di lavoro.
Una tendenza così marcata alla riduzione della partecipazione rischia di trasformarsi in un circolo vizioso, alimentando la stagnazione e impoverendo ulteriormente il tessuto socioeconomico regionale. In un contesto in cui l’offerta di lavoro si contrae, è rilevante analizzare i dati degli occupati. È proprio sul fronte dell’occupazione che si colgono con maggiore evidenza gli effetti della debolezza strutturale del mercato del lavoro calabrese.
Dinamiche dell’occupazione
L’andamento del numero di occupati evidenzia la persistenza di una traiettoria instabile, segnata da fragili progressi e brusche battute d’arresto.
Nel 1995 gli occupati in età 15–64 anni erano 558 mila; nel 2024 sono 521 mila: una riduzione netta di 37 mila unità (–6,6%) che, al netto delle fluttuazioni intermedie, fotografa un’economia incapace di generare occupazione in modo duraturo. Il primo decennio mostra un leggero incremento: dopo un avvio debole nella seconda metà degli anni ’90, si registra una fase espansiva tra il 2000 e il 2004, con un picco di circa 604 mila occupati nel 2004, massimo storico della serie. Questa crescita si rivela effimera: già nel 2005 inizia una fase di declino che, con la crisi finanziaria globale del 2008 e le politiche di austerità successive, determina un progressivo peggioramento. Tra il 2008 e il 2014 la Calabria perde circa 73 mila occupati, passando da 573 mila a 500 mila, con un crollo che riflette i limiti persistenti del contesto produttivo. Nel periodo 2015–2019 si osserva un recupero modesto ma costante, con un incremento di circa 25 mila occupati in cinque anni. Questa fase viene però interrotta dalla pandemia, che nel solo 2020 fa perdere oltre 22 mila posti di lavoro. A partire dal 2021 si assiste a un nuovo parziale recupero, che riporta il numero di occupati sopra le 520 mila unità nel 2024, ma senza superare i livelli del 2019. Nel complesso, nel 2024 il mercato del lavoro calabrese si presenta ancora su livelli inferiori a quelli raggiunti vent’anni prima.
Il dato più rilevante, tuttavia, è la tendenza di lungo periodo: in trent’anni la Calabria ha perso occupazione in valore assoluto, in un contesto nazionale e meridionale che, pur tra molte difficoltà, ha visto una lieve crescita. Dal 1995 al 2024, gli occupati sono aumentati del +18% nel Centro-Nord, del +4% nel Mezzogiorno, mentre in Calabria si è registrato un calo del 7% (Figura 6). Si tratta di una doppia divergenza: verso il Nord, che ha beneficiato di una crescita più stabile, e verso lo stesso Mezzogiorno, che nell’ultimo decennio ha mostrato una maggiore capacità di tenuta. La traiettoria calabrese evidenzia una condizione di progressiva marginalizzazione, in cui le crisi hanno effetti duraturi e una ripresa più lenta, debole e selettiva. Per completare il quadro, esaminiamo ora le dinamiche della disoccupazione, che è l’indicatore di sintesi del disallineamento tra offerta e domanda di lavoro.
Trent’anni di disoccupazione in Calabria: livelli e confronti
Nel trentennio 1995–2024, la disoccupazione in Calabria si è attestata su livelli persistentemente elevati, segnando uno dei tratti più distintivi e problematici dell’economia regionale. Calcolato come rapporto tra disoccupati e forza lavoro, il tasso di disoccupazione mostra tre fasi ben distinte.
Nella prima fase (1995–2007), il tasso cresce inizialmente fino a un picco del 22,2% nel 1999, per poi avviare una lenta discesa fino al 10,8% nel 2007 (Figura 7). L’andamento riflette un contesto economico in lenta ripresa, con un leggero miglioramento della domanda di lavoro, ma anche con dinamiche di scoraggiamento che iniziano a ridurre la forza lavoro. Nella seconda fase (2008–2014), in corrispondenza della crisi economico-finanziaria globale e della successiva recessione europea, la disoccupazione in Calabria aumenta in modo considerevole, passando dal 12,1% nel 2008 al 24,2% nel 2014, valore massimo della serie. Nel 2014 su 100 persone attive sul mercato del lavoro, ben 24 erano prive di una collocazione lavorativa. Questo picco coincide con una drastica perdita di occupati e con l’incapacità del sistema produttivo regionale di assorbire la forza lavoro in eccesso. La terza fase (2015–2024) mostra una riduzione graduale del tasso di disoccupazione: si passa dal 23,2% del 2015 al 13,3% del 2024.
È necessario verificare da cosa siano determinate le variazioni del tasso di disoccupazione, ossia se sono attribuibili alla contrazione della forza lavoro o a creazione di nuova occupazione. I dati in valore assoluto aiutano a interpretare meglio l’evoluzione del fenomeno.
La riduzione del tasso di disoccupazione riflette più un ritiro dal mercato che una ripresa occupazionale (Figura 4). I disoccupati erano poco meno di 100.000 nel 1995, raggiungono un picco di oltre 135.000 nel 2014, e calano a circa 80.000 nel 2024. Tuttavia, questo calo della disoccupazione non riflette un’espansione occupazionale: tra il 2014 e il 2024, infatti, gli occupati aumentano di appena 11.000 unità, mentre la forza lavoro si riduce di oltre 40.000. In altri termini, una parte della popolazione attiva ha cessato di cercare lavoro, determinando una flessione del tasso di disoccupazione solo apparente. Il calo del tasso di disoccupazione, quindi, non è segno di un miglioramento strutturale, ma il risultato combinato di debole dinamica occupazionale e ritiro dal mercato del lavoro, un fenomeno che impoverisce ulteriormente il tessuto produttivo e limita le prospettive di crescita regionale.
Il confronto con il resto del Paese conferma l’anomalia del mercato del lavoro calabrese. Nel 1995, la disoccupazione in Calabria era al 15%, contro l’11% dell’Italia e l’8% del Centro-Nord. Il divario si è mantenuto stabile nei decenni successivi, ampliandosi nei momenti di crisi: nel 2014, la Calabria ha toccato il 24,2%, mentre il tasso italiano era fermo al 13% e quello del Centro-Nord al 10%. Anche il confronto più recente restituisce una dinamica divergente: nel 2024, la disoccupazione in Calabria è ancora al 13,3%, contro l’8% della media nazionale, il 4% del Centro-Nord e il 12% del Mezzogiorno. La distanza dal Nord è oggi di quasi 10 punti, segno di una persistente fragilità strutturale. Come già osservato per la forza lavoro e l’occupazione, anche in questo ambito, la regione si conferma tra le più vulnerabili del Sud.
Sintesi finale: una lettura combinata degli indicatori
L’analisi congiunta dei principali indicatori del mercato del lavoro calabrese nel trentennio 1995–2024 restituisce un quadro di persistente fragilità strutturale. Nel 2024, la Calabria presenta un tasso di attività del 51,7% e un tasso di occupazione del 43,7%, valori che segnalano una scarsa inclusione della popolazione in età lavorativa nel circuito produttivo. Ciò implica che quasi la metà degli adulti tra i 15 e i 64 anni è inattiva, mentre tra chi è attivo, i disoccupati sono il 13,3%. Nel confronto nazionale, le distanze sono ampie e crescenti: nel Centro-Nord, il tasso di attività raggiunge il 73,1% e quello di occupazione il 69,1%, con un’incidenza dell’inattività decisamente inferiore. Questo divario non è solo quantitativo, ma qualitativo, e riflette una diversa capacità dei territori di attrarre, valorizzare e trattenere risorse umane. Particolarmente significativo è il dato relativo alla disoccupazione: il calo del tasso osservato tra il 2014 e il 2024 (dal 24,2% al 13,3%) è in larga parte dovuto alla contrazione della forza lavoro, più che alla creazione di nuovi posti di lavoro. In dieci anni, a fronte di appena 11.000 occupati in più, la forza lavoro si è ridotta di oltre 40.000 unità. È probabile, quindi, che parte dei disoccupati abbia abbandonato il mercato, determinando una riduzione del tasso senza che corrisponda un miglioramento delle condizioni economiche.
In estrema sintesi, la dinamica occupazionale calabrese segnala una fragilità strutturale del mercato del lavoro, incapace di assorbire la forza lavoro disponibile e soggetto a continui fenomeni di scoraggiamento degli “occupabili”. Il confronto con le altre aree del Paese conferma che non si tratta di una crisi ciclica, ma di una divergenza strutturale. In assenza di politiche mirate a rafforzare la base produttiva, creare nuove opportunità occupazionali, ridurre l’inattività e migliorare la qualità della domanda di lavoro, la Calabria rischia di consolidare ulteriormente il proprio ritardo. È necessario promuovere un cambiamento strutturale che favorisca lo sviluppo di settori ad elevata produttività, capaci di competere sui mercati globali delle merci e dei servizi. Solo una trasformazione profonda del modello di sviluppo potrà evitare che in Calabria si consolidi uno squilibrio territoriale persistente, con effetti cumulativi su crescita, coesione e sostenibilità sociale. (fa)