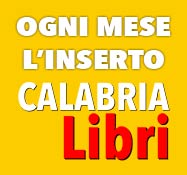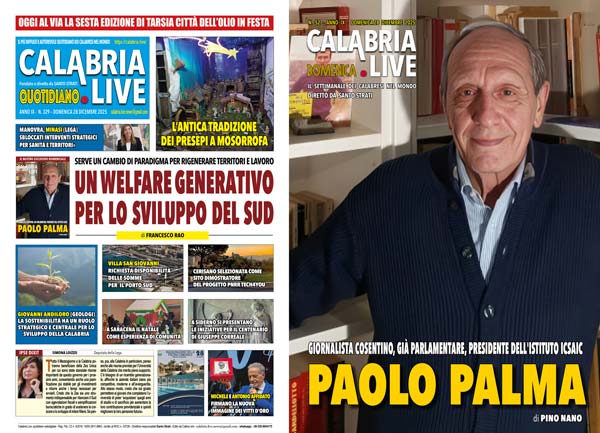di FRANCESCO AIELLO –
T
rent’anni rappresentano un orizzonte temporale sufficientemente ampio per valutare l’evoluzione strutturale di un sistema economico. Utilizzando dati macroeconomici a partire dal 1995, è possibile cogliere non solo gli effetti di lungo periodo dei mutamenti demografici e produttivi, ma anche la capacità dell’economia calabrese di reagire agli shock esogeni e ai cambiamenti del contesto nazionale. In questa prospettiva, il posizionamento della Calabria rispetto al Mezzogiorno, al Centro-Nord e all’Italia offre una chiave di lettura utile per comprendere meglio la natura e la persistenza dei ritardi che caratterizzano il modello di sviluppo dell’economia calabrese.
Il Pil pro capite: la sintesi del divario
Il Pil pro capite rappresenta una sintesi delle dinamiche demografiche e della capacità di generare valore economico. Nel 2023, il reddito per abitante a prezzi costanti 2015 si attesta in Calabria a 17.235 euro, in aumento rispetto ai 15.435 euro del 1995. La variazione, pari all’11,7%, è più bassa di quella del Centro-Nord (+14%) e con la media nazionale (+14,9%). Anche il Mezzogiorno, con un incremento dell’11,3% (da 17.814 a 19.824 euro), mantiene un livello di reddito pro capite più elevato di quello calabrese. Il PIL pro capite si può scomporre nel prodotto tra il tasso di occupazione e la produttività del lavoro (produzione per occupato). In Calabria, entrambi questi fattori hanno mostrato segnali di debolezza lungo tutto il trentennio: il tasso di occupazione è rimasto sistematicamente inferiore rispetto alle altre macroaree e la produttività ha registrato un andamento altalenante, spesso sostenuto da una riduzione del numero di occupati più che da una reale crescita della produzione.
Per comprendere meglio la traiettoria dello sviluppo della nostra regione, analizzeremo questi due elementi in dettaglio nei paragrafi 3-6. Ora, al fine di avere un ordine di grandezza dei divari territoriali, confrontiamo la Calabria con il Centro-Nord. Nonostante la crescita dell’11,7% che abbiamo osservato del Pil pro-capite calabrese, negli ultimi 30 anni il ritardo della Calabria si è ampliato: nel 1995 il Pilpro-capite regionale rappresentava il 58,5% di quello del Centro-Nord; nel 2023 tale rapporto scende al 48,4%. Si tratta di un indicatore chiaro dell’aggravarsi del divario territoriale. I dati consentono anche di osservare se in specifici sotto-periodi si sia avuta convergenza. Emerge che nonostante una moderata crescita fino al 2007, la dinamica del PIL pro-capite calabrese si appiattisce nella fase successiva. Nel decennio 2010–2019, il livello si stabilizza intorno ai 16.500–17.000 euro, mentre il Centro-Nord supera stabilmente i 34.000 euro. La crisi pandemica del 2020 accentua la fragilità del sistema regionale, con una caduta sotto i 16.000 euro, seguita da un recupero molto lento.
In estrema sintesi si può affermare che, rispetto ad altre macroaree, la Calabria ha beneficiato in misura marginale delle fasi di crescita e ha invece subito più duramente gli effetti degli shock. L’evidenza indica che il basso reddito pro capite è il risultato di una combinazione sfavorevole di crescita economica, produttività e demografia, ma rappresenta anche un freno allo sviluppo: limita gli investimenti, riduce i consumi e incentiva la migrazione di capitale umano.
Demografia e popolazione attiva: un declino strutturale
Il livello e l’andamento del Pil pro capite sono anche il riflesso delle dinamiche demografiche, che in Calabria appaiono particolarmente sfavorevoli. Nel periodo 1995–2023, la popolazione residente in Calabria si è ridotta da 2.063.300 unità nel 1995 a 1.850.366 nel 2023, registrando una flessione del 10,3%. La variazione negativa si distingue nettamente dal dato nazionale (+3,8%) e ancor più da quello del Centro-Nord, dove si è osservato un incremento dell’8,1%. Anche rispetto al Mezzogiorno, che nello stesso periodo ha perso il 3,8% della popolazione, la Calabria mostra più criticità.
Il declino demografico calabrese è continuo e privo di fasi di stabilizzazione significative. A partire dal 2000, l’indice relativo della popolazione scende costantemente, con un’accelerazione tra il 2003 e il 2005 e poi, in misura ancora più marcata, dal 2014 in avanti. Tra il 2014 e il 2023 il calo è di quasi 6 punti percentuali, segno di un processo di spopolamento intenso e strutturale. Nel frattempo, il Centro-Nord raggiunge un picco massimo nel 2017, mentre la Calabria continua a decrescere. A partire dal 2020 anche la popolazione italiana inizia a contrarsi, pur restando ben distante dalla dinamica negativa della Calabria. Nel complesso, la regione si caratterizza per una traiettoria divergente non solo rispetto al Centro-Nord, ma anche rispetto al resto del Mezzogiorno, configurandosi come una delle aree a maggiore contrazione demografica del Paese.
Lo spopolamento ha impatti rilevanti sull’offerta di lavoro, sulla domanda interna e sulla tenuta del sistema territoriale nel medio-lungo periodo. Per esempio, la popolazione in età lavorativa (15–64 anni) nel trentennio 1995–2024 ha sperimentato in Calabria una progressiva riduzione, passando da oltre 1.296.000 persone nel 1995 a circa 1.163.000 nel 2024. Si tratta di una perdita netta di circa 133.000 individui, pari a un calo del 10,3%. A titolo di confronto, la popolazione in età lavorativa si è ridotta del 4,2% in Italia, dell’1,6% nel Centro-Nord e dell’8,8% nel Mezzogiorno. La Calabria, con il suo -10,3%, si conferma come una delle regioni in cui la fragilità della popolazione in età lavorativa si è si è espressa in modo più netto.
Tutto ciò è l’esito di due fattori: da un lato l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, dall’altro i saldi migratori negativi, in particolare di giovani e adulti in età da lavoro. Il risultato è una riduzione non solo del numero di potenziali partecipanti al mercato del lavoro, ma anche della qualità della forza lavoro disponibile.
Partecipazione e occupazione: bassa l’aderenza al mercato del lavoro.
Nel 2024, la forza lavoro calabrese ammonta a 601.755 persone, mentre gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono 561.170. Su una popolazione complessiva in età lavorativa di circa 1.163.000 persone, quasi il 48% risulta inattiva. Un valore molto elevato per un’economia avanzata, che riflette una persistente difficoltà di attivazione del capitale umano. La configurazione attuale non rappresenta una novità: nel 1995 la forza lavoro era pari a 656.905 persone e gli inattivi 639.138, con un tasso di inattività del 49,3%. Dopo un parziale miglioramento tra il 1997 e il 2002, le due dinamiche si invertono e, con la crisi del 2008, gli inattivi sono di più della forza lavoro.
Lo stesso problema si può guardare dal lato del tasso di attività. Nel 1995, la Calabria registrava un valore del 50,7%, in linea con il dato medio del Mezzogiorno (50,8%), ma ben al di sotto del Centro-Nord (66,2%). L’indicatore cresce lentamente fino al 2008 (54,6%) per poi stabilizzarsi e tornare su valori simili a quelli di partenza. Nel 2024 è pari al 51,7%, appena un punto percentuale sopra il livello di trent’anni prima, mentre nel Centro-Nord si mantiene stabilmente oltre il 70%.
In altri termini, la Calabria fatica da tre decenni a coinvolgere stabilmente la propria popolazione attiva nel mercato del lavoro. Il dato riflette non solo una più debole partecipazione femminile, ma anche una radicata sfiducia nella possibilità di accesso al mercato del lavoro. La presenza di migliaia di persone in età attiva disimpegnate dalla partecipazione economica rappresenta uno dei principali vincoli allo sviluppo della regione.
Passando dal potenziale alla concreta utilizzazione della forza lavoro, la dinamica dell’occupazione rafforza la lettura “declinista” dell’economia calabrese. Nel trentennio si osserva una contrazione del numero di occupati da 559.000 nel 1995 a 540.000 nel 2024 (-19.000 unità). A differenza di quanto avviene nel resto del Paese, dove gli occupati aumentano (+4,7% in Italia, +10,3% nel Centro-Nord), in Calabria si registra una riduzione, che risulta particolarmente significativa tra il 2008 e il 2014 e nel biennio pandemico 2020–2021. Il picco massimo di occupazione si osserva nel 2008 con oltre 595.000 occupati. Il minimo è 510.000 unità riferito al 2014. Dopo una parziale ripresa, la crisi pandemica del 2020 determina un nuovo arretramento. Solo nel biennio 2022–2023 si osserva una certa stabilizzazione, ma i livelli restano inferiori a quelli di inizio periodo.
La dinamica calabrese si distingue da quella nazionale anche per una minore capacità di creare nuova occupazione in fase espansiva e per una maggiore vulnerabilità nei momenti di crisi. Questa evoluzione occupazionale, unitamente alla stagnazione della partecipazione, offre un quadro di persistente debolezza del mercato del lavoro calabrese. Più in generale, la traiettoria dell’occupazione in Calabria suggerisce una debolezza strutturale del sistema economico regionale, incapace di assorbire in modo stabile e crescente la forza lavoro disponibile. Il confronto con le altre aree del Paese evidenzia un ulteriore elemento di fragilità: la distanza tra la Calabria e il Centro-Nord in termini di tasso di occupazione è passata da 21 punti percentuali nel 1995 a 23 nel 2024, confermando l’assenza di processi di convergenza. In trent’anni, la Calabria ha sperimentato una delle peggiori performance occupazionali d’Italia, con effetti evidenti sulla coesione sociale e sulla capacità di attivare dinamiche di sviluppo.
Disoccupazione: livelli elevati e miglioramenti solo apparenti
Nel trentennio 1995–2024, la disoccupazione in Calabria si è attestata su livelli persistentemente elevati, rappresentando uno degli aspetti più problematici del mercato del lavoro regionale. Calcolato come rapporto tra disoccupati e forza lavoro, il tasso di disoccupazione segue tre fasi distinte.
La prima fase (1995–2007) è caratterizzata da un picco iniziale del 22,2% nel 1999, seguito da una graduale discesa fino al 10,8% nel 2007. Questo calo riflette un lento miglioramento della domanda di lavoro, ma anche un progressivo scoraggiamento che riduce la dimensione della forza lavoro. Nella seconda fase (2008–2014), coincidente con la crisi economico-finanziaria globale e la recessione europea, la disoccupazione cresce rapidamente: dal 12,1% nel 2008 si arriva al 24,2% nel 2014, valore massimo della serie. Un dato che evidenzia la drastica perdita di occupati e l’incapacità del sistema produttivo di assorbire l’eccesso di offerta di lavoro. La terza fase (2015–2024) mostra un miglioramento apparente: il tasso scende progressivamente dal 23,2% al 13,3%. Tuttavia, questa riduzione è in larga parte attribuibile al ritiro dal mercato del lavoro di molte persone occupabili. Tra il 2014 e il 2024, gli occupati aumentano di appena 11.000 unità, mentre la forza lavoro si riduce di oltre 40.000. Una parte dei disoccupati ha dunque smesso di cercare lavoro, determinando una flessione del tasso di disoccupazione non accompagnata da una vera ripresa occupazionale.
In valore assoluto, i disoccupati erano poco meno di 100.000 nel 1995, superano i 135.000 nel 2014 e scendono a circa 80.000 nel 2024. Anche qui, il minor numero di disoccupati non riflette un’espansione occupazionale robusta, ma piuttosto una contrazione della partecipazione economica.
Il confronto con il resto del Paese conferma l’anomalia calabrese. Nel 1995, il tasso di disoccupazione in Calabria era al 15%, contro l’11% dell’Italia e l’8% del Centro-Nord. Nel 2014, la Calabria raggiunge il 24,2%, mentre l’Italia si ferma al 13% e il Centro-Nord al 10%. Nel 2024, il tasso calabrese è ancora al 13,3%, a fronte dell’8% nazionale, del 4% nel Centro-Nord e del 12% nel Mezzogiorno. Il divario con il Centro-Nord è oggi di quasi 10 punti percentuali.
Si ha, quindi, qualche conferma che la riduzione della disoccupazione, quando si manifesta, non segnala un miglioramento strutturale, ma riflette fenomeni di scoraggiamento e fuoriuscita dal mercato del lavoro, che impoveriscono ulteriormente il tessuto produttivo e limitano le prospettive di sviluppo regionale.
Valore aggiunto aggregato: una crescita discontinua e debole
Espresso a prezzi costanti 2015, il valore aggiunto della Calabria passa da 28,6 miliardi di euro nel 1995 a 29 miliardi nel 2023, con un incremento cumulato del +1,7%. Si tratta di una crescita molto contenuta, soprattutto se confrontata con l’aumento osservato a livello nazionale (+21%), nel Mezzogiorno (+8,7%) e, in misura ancora più marcata, nel Centro-Nord (+25%). Questo divario evidenzia la bassa capacità del sistema produttivo regionale di generare espansione economica nel lungo periodo, anche in un contesto di stabilità macroeconomica.
L’evoluzione temporale consente di distinguere diverse fasi. Tra il 1995 e il 2007, la Calabria registra una crescita in linea con le altre macroaree: nel 2007 l’indice supera quota 115, poco al di sotto della media nazionale. Tuttavia, la crisi del 2008–2009 rappresenta un primo punto di discontinuità. Mentre il Centro-Nord recupera rapidamente (superando quota 120 già nel 2010), la Calabria entra in una fase di stagnazione e poi di declino. Un secondo momento di frattura si osserva a partire dal 2012: mentre l’Italia e il Centro-Nord riprendono gradualmente a crescere, la Calabria e l’intero Mezzogiorno seguono una traiettoria divergente. Il valore aggiunto della Calabria si contrae quasi ininterrottamente fino al 2020, anno della pandemia, in cui tocca il minimo relativo (indice intorno a 87). In nessun’altra area del Paese si osserva una caduta così profonda. La ripresa successiva, pur visibile, è più contenuta: nel 2023 l’indice calabrese è ancora al di sotto del livello del 2007 e poco al di sopra del valore del 1995.
I dati del valore aggiunto aggregato segnalano la fragilità della struttura produttiva regionale, incapace di resistere agli shock esogeni e poco reattiva nelle fasi di espansione. In questo contesto, la distanza accumulata rispetto al Centro-Nord e al dato nazionale assume una valenza strutturale, non più solo congiunturale.
La produttività del lavoro: una crescita senza convergenza
Ulteriori importanti elementi di valutazione sono forniti dalla produttività del lavoro, espressa come valore aggiunto per occupato a prezzi costanti 2015. Questo indicatore mostra che l’Italia è un paese a bassa crescita e che i divari territoriali di sviluppo rimangono ampi, senza alcun significativo segnale di convergenza.
Nel 2023, la produttività del lavoro in Calabria è pari a 55.882 euro, nettamente inferiore a quella del Centro-Nord (75.071 euro), del dato nazionale (70.786 euro) e del Mezzogiorno (58.854 euro). Il divario con il Centro-Nord rimane ampio: nel 1995 la produttività calabrese era il 73,2% di quella settentrionale; nel 2023 è al 74,4%. Questo andamento conferma nuovamente che, in trent’anni, nessuna vera convergenza si è realizzata.
Anche il tasso medio annuo di crescita della produttività conferma la stagnazione: in Calabria è pari a +0,31%, poco sopra il dato nazionale (+0,26%) e superiore a quello del Centro-Nord (+0,25%) e del Mezzogiorno (+0,22%). Tuttavia, si tratta di un incremento debole, privo di un rafforzamento strutturale: la Calabria parte da livelli molto più bassi e non riesce a ridurre significativamente i divari.
Le traiettorie temporali confermano questa lettura. Tra il 2015 e il 2020 la produttività del lavoro in Calabria si contrae da un massimo di 58.493 euro a un minimo di 52.743 euro, con un calo di circa il 10% in cinque anni. Questo arretramento precede l’impatto pandemico, che nel 2020 ha ulteriormente aggravato la situazione. Solo dal 2021 si osserva una parziale ripresa, ma i livelli del 2023 restano inferiori a quelli del 2015. L’analisi comparata evidenzia come le fluttuazioni calabresi riflettano una struttura economica esposta a shock esterni, con bassa capacità di adattamento e scarsa resilienza. È anche utile osservare che le dinamiche della produttività sono spesso l’esito di una contrazione dell’input lavoro piuttosto che di un’espansione reale dell’output. In più fasi – come tra il 2008 e il 2014 e tra il 2016 e il 2019 – la produttività appare sostenuta da una riduzione degli occupati, non da un rafforzamento del valore aggiunto aggregato. Nel confronto con il Centro-Nord, emerge con estrema chiarezza questa differenza: in Calabria la produttività cresce, quando cresce, “per sottrazione”, ossia in presenza di un calo dell’occupazione; al contrario, nel Centro-Nord la crescita è più stabile e coerente con una dinamica di lungo periodo sostenuta da investimenti, innovazione e capacità di adattamento. In sintesi, in Calabria la produttività rimane fragile, discontinua e incapace di contribuire a una crescita duratura.
Le cause strutturali del declino: una specializzazione poco orientata alla crescita
L’analisi della struttura economica regionale evidenzia una specializzazione settoriale che non favorisce la crescita. In Calabria, dominano ancora comparti a bassa produttività come i servizi tradizionali, la pubblica amministrazione e l’agricoltura, mentre risultano sottodimensionati i settori più dinamici, come la manifattura in senso stretto e i servizi ad alta intensità di conoscenza. Nel 2022, l’industria manifatturiera rappresenta solo il 3,8% del valore aggiunto regionale, una quota significativamente inferiore rispetto a quella del Centro-Nord, dove i valori sono più che tripli. Questo comparto ha subito una marcata contrazione: per esempio tra il 2010 e il 2021, il numero di imprese manifatturiere si è ridotto di circa 1.400 unità, mentre gli investimenti si sono contratti del 41%. La marginalità della manifattura compromette la capacità della regione di partecipare alla produzione di beni a domanda globale e ai processi di innovazione industriale. A ciò si aggiunge il peso relativamente elevato dell’agricoltura, che in Calabria rappresenta il 4,4% del valore aggiunto, contro una media nazionale molto più bassa. Anche il settore pubblico incide in modo rilevante: amministrazione pubblica, difesa e istruzione generano il 21,7% del valore aggiunto, a fronte del 14,9% nel Centro-Nord. Analogamente, il terziario tradizionale (commercio, alloggio, ristorazione, trasporti e servizi alla persona) incide per il 32,4%, rispetto al 25,6% del Centro-Nord.
Questa configurazione settoriale penalizza la capacità di crescita: le attività più presenti in Calabria sono, per struttura e dinamica, meno esposte alla concorrenza e meno connesse con le catene globali del valore. La scarsa presenza della manifattura – il comparto che più di altri contribuisce all’innovazione e all’export – è un limite storico e strategico. Le imprese industriali, quando presenti, sono di piccola dimensione, scarsamente capitalizzate e poco orientate ai mercati esterni. Nel complesso, la specializzazione produttiva della Calabria non si è tradotta in vantaggi competitivi né in dinamiche espansive. Al contrario, ha reso il sistema economico più vulnerabile alle crisi e meno reattivo nelle fasi di ripresa. Il risultato è un equilibrio di lungo periodo caratterizzato da bassa produttività, crescita modesta e debole domanda interna, alimentando una spirale negativa difficile da invertire.
Alcune conclusioni
L’analisi dell’evoluzione macroeconomica della Calabria negli ultimi trent’anni restituisce l’immagine di una regione che ha faticato a mantenere il passo con il resto del Paese. Il calo demografico, la stagnazione dell’occupazione e la debolezza della partecipazione al mercato del lavoro si combinano con una crescita del valore aggiunto modesta e una produttività del lavoro instabile, spesso sostenuta da dinamiche legate al ridimensionamento della base occupazionale più che da trasformazioni strutturali.
Il divario rispetto al Centro-Nord non si è ridotto, anzi in alcune dimensioni si è ampliato. L’assenza di processi di convergenza dipende in misura prevalente da una composizione strutturale in cui il settore manifatturiero in senso stretto contribuisce con una quota irrisoria alla creazione del valore aggiunto aggregato, mentre dominano i settori a bassa produttività (agricoltura, servizi maturi, pubblica amministrazione): si tratta di un modello di specializzazione che, evidentemente, non ha saputo assorbire adeguatamente la forza lavoro disponibile, non è stato in grado di adottare o produrre innovazione e, quindi, non ha generato crescita sostenibile.
L’analisi degli ultimi 30 anni suggerisce che la debolezza del sistema economico calabrese ha radici profonde e richiede interventi mirati non solo sul lato delle politiche pubbliche, ma anche su quello dell’organizzazione produttiva e di scelte industriali selettive. In un contesto di persistente fragilità demografica e occupazionale, l’attrazione di investimenti extraregionali e la valorizzazione del capitale umano appaiono condizioni necessarie per favorire un cambiamento strutturale dell’economia calabrese. Per interrompere la spirale regressiva che ha segnato la storia della regione, sarà indispensabile puntare sulla produzione di beni a domanda globale e ad alto contenuto tecnologico e su servizi ad elevata professionalizzazione. In assenza di questa “rivoluzione” del modello di sviluppo dell’economia calabrese, tra trent’anni ci ritroveremo a commentare i dati macroeconomici di una regione ancora più piccola, più povera e più assistita. (fa)
[Courtesy il Quotidiano del Sud – L’Altra Voce]