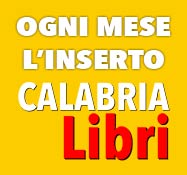di GIACINTO NANCI – Il dott. Ernesto Esposito, secondo commissario alla sanità calabrese in applicazione del Piano di Rientro Sanitario della Calabria, ci ha informati che il governatore-commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, ha avuto “particolare attenzione” per la Asp di Vibo Valentia nei criteri di riparto dei fondi sanitari alle Asp calabresi perché «il riparto tra le Asp è stato definito… non più sulla spesa storica. Si è scelto, invece, di considerare la popolazione pesata e l’indice di deprivazione che è uno strumento statistico che misura il livello di svantaggio socio economico di una popolazione combinando diversi indicatori relativi a condizioni di vita e di istruzione».
Ebbene, in base a questa “particolare attenzione” che il commissario Occhiuto (e anche il secondo commissario Ernesto Esposito) hanno avuto per Vibo, il riparto sanitario pro capite per ogni vibonese è stato di 1.551 euro ben (??????) 60 euro in più della provincia di Cosenza, che ha avuto 1.491 euro (la provincia che ha avuto di meno) e 25 euro in meno della provincia di Reggio Calabria (la provincia che ha avuto di più) 1576 euro pro capite. Non sappiamo cosa ci possano fare i vibonesi per curarsi meglio con 60 euro pro capite in più dei cosentini, ci sembra più una presa in giro, visto che queste dichiarazioni sono state fatte, in presenza del Prefetto, ai delegati della manifestazione sul degrado della sanità vibonese. Intanto, i criteri di riparto dei fondi, citati dal secondo commissario Esposito, non sono una rivoluzione ma è ciò che da sempre applica la Conferenza Stato-Regioni per stabilire il riparto dei fondi sanitari alle regioni. Infatti, il 98,5% dei fondi la conferenza li fa sulla «popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per classi di età, lo 0,75% sul tasso di mortalità della popolazione inferiore ai 75 anni e lo 0,75% sull’incidenza della povertà relativa individuale, l’incidenza della bassa scolarizzazione nella popolazione di età maggiore dei 15 anni e infine il tasso di disoccupazione». In pratica Occhiuto ha avuto nei confronti dei vibonesi la stessa “sensibilità” che ha da sempre la Conferenza Stato-Regione nei confronti della Calabria, perché sono proprio questi criteri di riparto che hanno sottofinanziato la sanità calabrese da più di 20 anni a questa parte. Per rendere l’idea del grave sottofinanziamento della sanità calabrese, basta citare i dati della “spesa primaria netta in sanità per regioni (media 2000-2018 euro pro capite) elaborata dai Centri Pubblici Territoriali del Sistan (sistema statistico nazionale) nei quali si vede che la Calabria ha speso 1.614 euro pro capite a fronte della Lombardia che, invece, ha speso 2.217 euro pro capite, cioè ben 603 euro in più della Calabria. Se noi avessimo avuto i finanziamenti della Lombardia avremmo potuto spendere ogni anno dal 2000 al 2018 ben (603×1.949.000) 1 miliardo centosettantacinque milioni in più. Per quanto riguarda il concetto della “deprivazione” (quella vera) nel 2016 l’allora presidente della Conferenza Stato-Regioni, on. Bonaccini, ne decise una sua “parzialissima” applicazione del criterio di riparto dei fondi sanitari alle regioni per quell’anno.
Ebbene, nel 2017 in base a questa “parzialissima” applicazione alla Calabria sono arrivati 29 milioni di euro in più del 2016 e in tutto il Sud ben 408 milioni di euro in più. Il concetto della deprivazione non è stato né ampliato né riproposto negli anni successivi. Ma il grave sotto finanziamento della sanità calabrese dipende ancora di più dal fatto che nei circa 2 milioni di calabresi ci sono ben trecentomila malati cronici in più che non in altri due milioni di altri italiani. Quindi, dove ci sono stati e ci sono molti più malati cronici sono arrivati e arrivano meno fondi per poterli curare e, di questo, tutti ne sono a conoscenza perché, oltre che da tutti gli istituti di statistica sanitaria, è stato certificato anche da uno dei colleghi del commissario Occhiuto già nel lontano 2015 quando il commissario al piano di rientro sanitario ing. Scura ha firmato il Dca n. 103 del 30/09/2015. Arrivano meno fondi sanitari (Calabria) proprio dove ci sono molti più malati cronici (sempre Calabria) nonostante ci sia una legge (mai applicata) n. 662 del lontano 1996 che, al punto cinque del comma 34 dell’art. 1, dice proprio che uno dei criteri del riparto dei fondi sanitari deve essere fatto in base alla epidemiologia cioè più fondi dove ci sono più malati cronici e non il contrario per come è avvenuto per più di un ventennio, cosa che il secondo commissario Esposito dovrebbe sapere perché ha gestito anche la sanità della Campania che è stata trattata in modo ingiusto forse più della Calabria. Quindi, se il commissario Occhiuto e il secondo commissario Esposito vogliono davvero fare qualcosa per i malati vibonesi e calabresi tutti, dovrebbero andare alla Conferenza Stato-Regioni e pretendere con determinazione che venga applicato il criterio di riparto dei fondi basato sulla numerosità dei malati cronici per come recita la legge 662, altrimenti le dichiarazioni del secondo commissario Esposito suonano come la beffa in aggiunta al danno.
(Medico di Famiglia in pensione ed ex medico ricercatore Health Search)