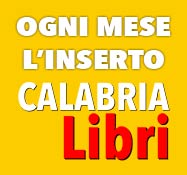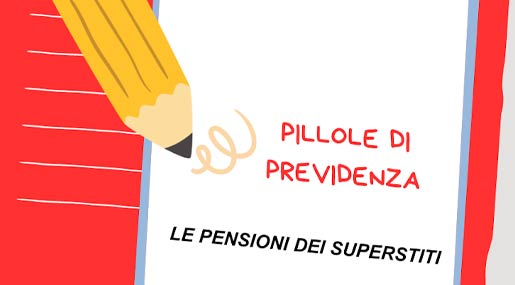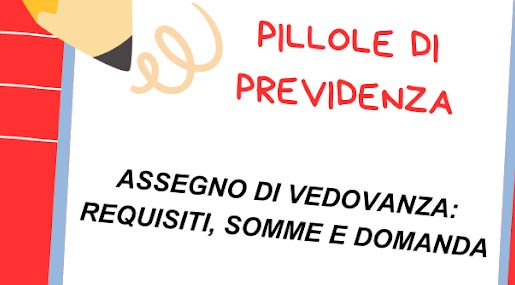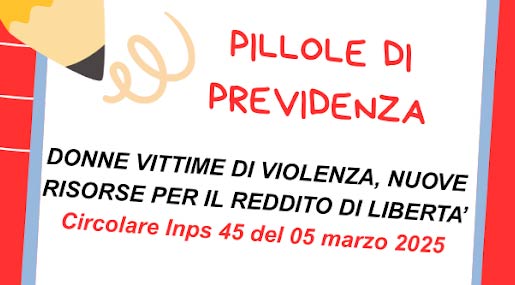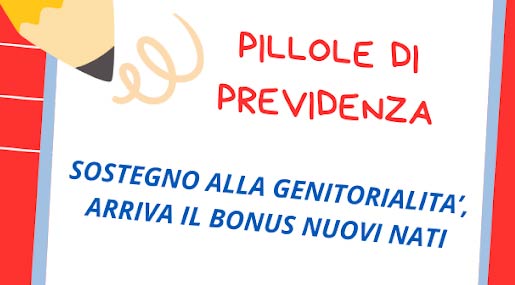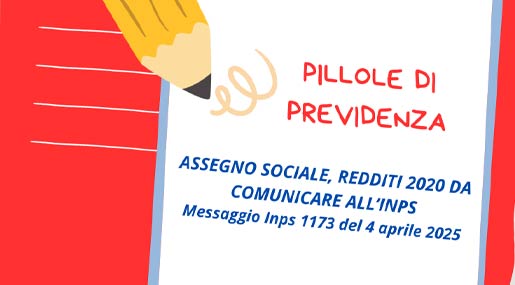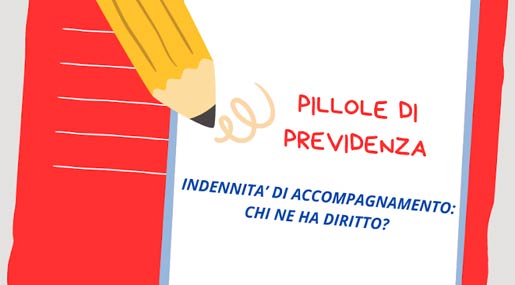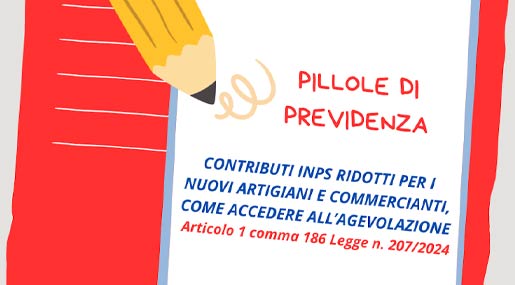di UGO BIANCO –
In caso di decesso di un pensionato o di un lavoratore, il sistema previdenziale italiano tutela i familiari superstiti attraverso specifiche prestazioni economiche.
L’Inps eroga la pensione di reversibilità quando la persona deceduta è già titolare di trattamento pensionistico, mentre riconosce la pensione indiretta quando il decesso riguarda un lavoratore assicurato, non ancora in pensione. Di seguito vengono illustrati i principali requisiti e le condizioni per accedere a queste prestazioni. Le regole si applicano ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, agli artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli, alla gestione separata ed ai dipendenti pubblici. In linea generale, tali disposizioni valgono anche per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome (ad esempio avvocati, medici, notai), pur con alcune differenze legate all’autonomia regolamentare.
Quali sono i requisiti?
Il diritto alla pensione di reversibilità è garantito quando il “de cuius” è titolare di una pensione diretta, come la vecchiaia, l’anticipata, la supplementare o l’inabilità. In caso di pensione indiretta, l’assicurato, deceduto, deve avere almeno 15 anni di contribuzione in tutta la carriera lavorativa oppure 260 settimane di contributi, di cui almeno 156 negli ultimi 5 anni precedenti il decesso. Sono validi i contributi obbligatori, figurativi o da riscatto, mentre i soli contributi volontari non danno diritto alla prestazione.
Chi sono i beneficiari?
Hanno diritto alla pensione ai superstiti: il coniuge o la persona unita civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato, a condizione che percepisca l’assegno divorzile, non si sia risposato e che il primo contributo previdenziale del defunto sia stato versato prima della sentenza di divorzio.
I figli e gli equiparati, nelle seguenti condizioni: minorenni alla data del decesso del genitore; inabili al lavoro e a suo carico al momento del decesso, indipendentemente dall’età; maggiorenni studenti, a suo carico, non lavoratori, che frequentano scuole o corsi di formazione equiparabili all’istruzione scolastica, fino al compimento del 21° anno di età; maggiorenni studenti universitari, a suo carico, non lavoratori, che frequentano l’università entro la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il 26° anno di età;
Il superstite è considerato a carico del defunto se sussistono condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Ai fini dell’accertamento, è rilevante anche la convivenza con il deceduto.
In mancanza del coniuge e dei figli, ha diritto alla prestazione, il genitore dell’assicurato/pensionato, se al momento del decesso ha almeno 65 anni, non essere titolari di pensione e risulta a suo carico. Gli aventi diritto possono essere anche i fratelli celibi e le sorelle nubili, se inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto, in assenza di coniuge, dei figli o dei genitori.
Quanto spetta?
L’importo lordo della prestazione, calcolato sulla pensione diretta o sul montante contributivo, è così suddiviso:
Quali sono i limiti reddituali?
Gli importi delle pensioni ai superstiti (a favore di coniuge, genitori, fratelli e sorelle) sono cumulabili con i redditi del beneficiario entro i limiti previsti dalla Tabella F della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 41). Di seguito si riportano le soglie reddituali, valide per il 2025, corrispondenti alla percentuale di riduzione applicata:
Qual è la decorrenza?
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato.
Quando si perde il diritto?
Il diritto alla pensione ai superstiti può cessare in diverse situazioni, tra cui: Nuovo matrimonio del coniuge; al compimento di 21 anni, per il figlio studenti di scuola secondaria o corsi equivalenti. Al compimento di 26 anni, se studente universitario oppure in caso di interruzione o conclusione degli studi prima di tali limiti; la perdita del riconoscimento dell’inabilità; Il superamento delle soglie massima di reddito prevista per la cumulabilità; nuovo matrimonio o se vengono meno i requisiti di inabilità, convivenza o carico economico, per fratello o sorella.
Come si richiede?
La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica:
Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali SPID, CIE o CNS; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]