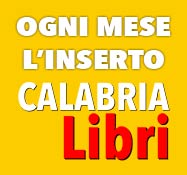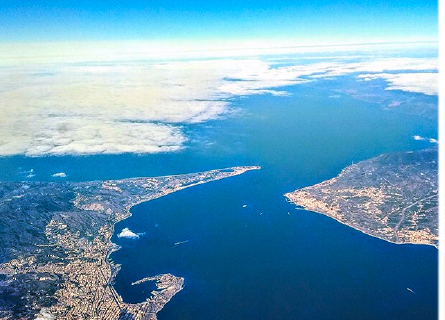Ritardi nell’avanzamento della spesa dei fondi europei. Lo stato di attuazione del programma 2021-2027 del fondo europeo di sviluppo regionale (Fers), vede la Regione Calabria ferma all’1,31% nell’avanzamento dei pagamenti e al 3,59% per ciò che concerne gli impegni di spesa. Che tradotto in soldoni significa che dei 2.405,17 miliardi destinati alla Calabria, le risorse impegnate ammontano a 86,37 milioni mentre i pagamenti non vanno oltre i 31,40 milioni.
Va un po’ meglio per quanto riguarda invece i fondi Fse+: l’avanzamento degli impegni segna il 7,01% mentre quello dei pagamenti il 5,93%. Sono questi alcuni dei dati che emergono da Check-Up Mezzogiorno 2024, l’analisi sullo stato di salute dell’economia meridionale realizzato annualmente da Confindustria e SRM.
Fondi europei
I dati relativi all’attuazione della programmazione 2021-2027 soprattutto nelle regioni del Sud sono ancora molto bassi, seppur ci si trovi quasi alla revisione di metà periodo. Questo – secondo l’associazione degli industriali – «è sicuramente imputabile a varie cause, primo tra tutti il fatto che la programmazione è di per sé partita con due anni di ritardo a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia, che ha interrotto i negoziati sui regolamenti e di conseguenza l’approvazione del quadro legislativo europeo e poi dell’Accordo di partenariato e dei piani nazionali e regionali». Inoltre, «la concomitanza con l’introduzione del Pnrr ha portato le amministrazioni a spendere per prime, per non perderle, tali risorse». Al 31 dicembre 2024 sono i programmi regionali delle regioni classificate come “più sviluppate” a far registrare il tasso più alto di risorse impegnate (30,9%) e di pagamenti effettuati (10%, il doppio della media nazionale). Con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, il dato complessivo è pari all’11% di impegni e al 3% di pagamenti, con una performance migliore per i Piani Nazionali. «Questo andamento eterogeneo – rilevano gli industriali – è sicuramente anche imputabile al fatto che le risorse a disposizione sono molte di più nelle regioni classificate come meno sviluppate».
Tra queste, registrano buone performance i FSE + di Puglia e Campania. In linea generale, l’attuazione del FESR, e quindi del fondo più specificatamente a sostegno delle imprese, è ferma a un 1,5%, dato ben al di sotto della media nazionale.
Accordi per la Coesione, Calabria da zerovirgola
Introdotti nel 2023, gli Accordi per la Coesione costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. A differenza che nel passato, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo vengono concordati tra le Amministrazioni e il Governo.
«Il necessario tempo per la negoziazione degli accordi – si legge nel report – ha portato alla stipula degli stessi con tempi diversi da regione a regione, comportando inevitabilmente effetti sull’attuazione».
A livello nazionale i pagamenti non arrivano ancora all’1%, mentre a livello regionale nel Sud spicca la Basilicata, con un livello di pagamenti pari al 3%. Mancano i dati relativi all’attuazione degli Accordi in Campania e Sardegna, in quanto la firma stessa dell’accordo in queste due Regioni è arrivata tardivamente e non sono stati elaborati ancora i dati sui pagamenti. Mentre la Calabria è ferma allo 0,03% sui pagamenti e allo 0,09 sugli impegni.
Crescono le società di capitali: +4%
A fine 2024 le imprese attive nel Mezzogiorno erano più di 1 milione e settecentomila e, pur se in lieve calo rispetto al dato del 2023 (-1,2%), rappresentano poco più di un terzo del totale nazionale. Le Società di capitali al Sud continuano, invece, a mostrare un andamento in crescita, superando le 425 mila unità, con un +4,2% rispetto all’anno precedente che equivale ad oltre 17 mila nuove imprese di capitale. Per tutte le regioni della macroarea la dinamica è la stessa: ad un calo del numero complessivo di imprese si contrappone una crescita delle società di capitaliche mostrano le migliori performance in Campania (+4,8%), Puglia (+4,6%), Calabria (+4,1%). Dal Pollino allo Stretto le imprese attive nel 2024 sono state 157.410, in calo dell’1,7% rispetto al 2023 mentre le società di capitali hanno toccato quota 32.431.
Export
Nel 2024 l’export delle regioni del Sud è stato pari a quasi 65 miliardi di euro, circa l’11% del dato nazionale, con un calo rispetto al 2023 (-5,4%, contro un -0,6% per il Centro-Nord) ed un saldo commerciale negativo per quasi 5,5 miliardi. Guardando alle sue regioni, le prime due per flussi internazionali in uscita (Campania e Sicilia) rappresentano più della metà dell’export della macroarea; in particolare, la Campania registra un valore di oltre 21,6 miliardi di euro con un calo del 2,5% rispetto al dato del 2023 e la Sicilia un valore di quasi 13,2 miliardi con un calo dell’8,3%. La Calabria, invece, ha registrato un dato pari a 965 milioni con una variazione in positivo rispetto al 2023 del 9,4% e un saldo commerciale negativo pari a -267,3.
Occupazione
I dati sull’occupazione mostrano che, al 2024, nel Mezzogiorno si è concentrato quasi il 27% dell’occupazione nazionale e il 23,5% di quella femminile, valori decisamente più bassi se rapportate alla quota della popolazione che vive al Sud. Guardando all’andamento rispetto allo scorso anno, l’occupazione nel Mezzogiorno aumenta del 2,2%, un valore più alto di quello registrato nelle restanti aree del Paese (Centro-Nord +1,2%), superando le 6,4 milioni di unità. Anche l’occupazione femminile mostra segnali positivi con un +3,3% per oltre 2,4 milioni di unità. L’occupazione in Calabria rispetto al 2023 aumenta dello 0,4%.
La Zes Unica vola solo in Campania
Sul versante delle policy poste in essere per il Mezzogiorno, attraverso strumenti di agevolazione contributiva, di sgravi fiscali e di semplificazione amministrativa, uno tra i più rilevanti è senza dubbio il credito di imposta per gli investimenti effettuati nella Zes Unica.
I dati a consuntivo dell’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni di richiesta nel 2024 raccontano di poco meno di 7 mila domande pervenute dalle imprese localizzate nelle otto regioni meridionali, con una forte concentrazione in Campania, che, da sola, ha assorbito oltre un terzo delle domande. Seguono Sicilia e Puglia (quest’ultima con un numero di comunicazioni che non va oltre la metà della Campania). Abruzzo, Basilicata e Molise, sommate, non arrivano al 10% del totale.
A questo numero di domande è corrisposto un credito di imposta di poco superiore ai 2,5 miliardi di euro, che ha determinato un importo medio di circa 370 mila euro ad azienda richiedente. Quest’ultimo valore è in realtà specchio di una realtà piuttosto diversificata tra le varie regioni, in virtù delle diverse intensità di incentivo previste ma anche della diversa struttura produttiva e delle tipologie di investimenti effettuati: in Abruzzo, ad esempio, il credito medio concesso è meno della metà di quello di regioni come Sicilia, Calabria e Puglia (tra loro molto simili e in linea con il dato medio dell’intero Sud). (bam)
[Courtesy LaCNews24]