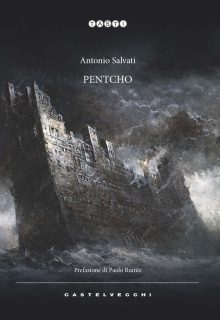di FRANCESCA OREFICE – La storia può essere raccontata come un fatto, dandole veste di accadimenti che si susseguono, di cose che succedono, di eventi. Ma non è l’unico modo, perché al contrario può essere vissuta: e così diventa memoria individuale, verbi che si svolgono in prima persona, tempi che ritornano al presente.
È questa la strada – non solo in senso metaforico – del Pentcho, lo sgangherato battello stracarico di ebrei in fuga da una Bratislava minacciata all’avanzata nazista che dà il suo nome al primo romanzo di Antonio Salvati, edito da Castelvecchi.
Nelle pagine di questa epopea le parole assumono un ruolo fondamentale, soprattutto quando raccontano e descrivono i punti di vi(s)ta di chi racconta la storia: donne, uomini, anche neonate.
E tutta la trama del racconto è svolta e dotata di senso da parole chiave, importanti, determinanti, che delineano il percorso della memoria che l’autore ci accompagna a (ri)vivere.
Così, lentamente, appena il Pentcho lascia il porto di Bratislava in un silenzio irreale rotto solo dall’ Ha-Tikvah, il canto della speranza, il racconto si umanizza, e si muove: dal passato al presente, dal libro alla bocca, dalle parole al corpo, dalle lettere al senso.
Credo che Antonio Salvati abbia scelto questa prospettiva (anzi, ben ventiquattro prospettive: tante quante le voci narranti, una per capitolo) per decifrare un racconto storico per un ben preciso convincimento.
L’idea è dire a gran voce, in questo modo, che le cose dell’umanità ri-guardino tutti, debbano appartenere alla nostra narrazione di e da persone o, almeno, soprav-vivere come memoria: le parole chiare delle cose dell’umanità, belle come sono belle, devono poggiarsi sulle labbra di ciascuna/o di noi, da qualunque posto o storia pro-vengano, e possono – debbono? – essere ri-viste, ri-vissute, ri-generate, comprese e ri-comprese.
L’autore, costruendo questa intelaiatura di narrazioni diverse, queste cose ci costringe a leggerle, coniugate in prima persona, e ci trasforma tutti fin dal primo rigo da lettrici e lettori in attrici e attori della storia (umana) che si racconta.
Grazie a una narrazione che non conosce cali di tensione e di attenzione, seguendo il percorso del Pentcho la memoria diventa reale: un suono, un pezzo di corpo, e stanzia sulla bocca, sotto il palato e sulla lingua, non soltanto dentro il libro.
E l’autore ce le fa dire, quelle parole, anche quando non sono più belle, quando diventano scomode, sfrontate, contaminate dalle altre cose del mondo, quelle che non recitano il verso della giustizia, e nel momento in cui diventano indicibili ed oscene (e sarebbe più comodo farle dire ad altre/i).
Nel libro c’è persino chi osserva amaramente che, a furia di essere stolidamente ripetute, le parole delle cose brutte, eliminate quelle belle, alla fine trionfano, generando convinci-menti, il più delle volte paure: ‘eccola, quindi la formula magica, dovevamo avere paura” (Alexander Citrom, studente).
E’ per questa strada ben conosciuta ma dal terribile fascino mai come oggi attuale che le parole brutte si saldano tra loro, diventando fondamento di stereotipi che attivano diseguaglianze, così come di odio, discriminazioni, schemi del pensiero pigro che hanno legiferato – e ancora accade – di razze migliori o peggiori, di persone elette e schiave, di privilegiati e abusati (“ascolteremo ancora dotti e scienziati costruire teorie sulla superiorità di un popolo, di una cultura su un altro, su tutti gli altri […] e poeti e scrittori e romanzieri pronti a comporre versi e romanzi per dare loro ragione” Julia Kunstlinger Presser, avvocatessa).
Il Pentcho, la sua storia, prova ad ammonirci che in questo modo le conseguenze sono quelle che la storia ci ha raccontato e che la vista, ahimè, ci pone in rassegna ancora oggi: ‘all’inizio perdono valore quelle buone, quelle che ti avvicinano all’altro. Sussurrate a voce sempre più bassa finiscono piano piano per sparire, travolte dall’imbarazzo di chi ha timore ad usarle per non apparire debole, ingenuo. O peggio, traditore. A quel punto, il loro posto viene occupato dalle altre, da quelle cattive’ (ancora lo studente Alexander Citrom).
Le parole, dicevamo, “già le parole. Dipende tutto da loro”!
E in questo libro le parole generano senso e contengono le ragioni del viaggio, della fuga, che inizia proprio sulle acque del Danubio, ventre materno e matrigno nella cui placenta scorre liquido il destino, il caso, la decisione divina o diabolica, o schiettamente laica, di come andrà la vita di ciascun passeggero, che poi siamo noi: “ognuno di noi ha un percorso stabilito da qualche parte, una specie di quaderno che gli viene consegnato quando viene al mondo’ (Alexander Orenstein, medico).
La narrazione, svelata da un linguaggio lineare – mai che manchi un pezzo o ne avanzi qualcuno – eppur liricamente ricercata ed emotivamente compromettente, svolge la propria trama sul percorso della paura, irrobustendo, da quella origine, sagome e fattezze ad un racconto che si personifica, parola per parola, sentimento per sentimento, senso per senso.
Attuale come una ferita che non guarisce, frutto di una malattia che non trova cura e infierisce su un corpo rassegnato al dolore di storie che ripetono la storia, la materia del racconto trova spazio e forma antropica tesa dalla pressione della paura, quella talmente devastante e straziante che, ancora oggi, nemmeno un po’ meno di ieri, co-stringe esseri umani ad aggrapparsi a una bagnarola, a una zattera, addirittura all’ala di un aereo: senza nessuna speranza, a cercare una speranza.
A dominare il viaggio del Pentcho, come dimostrano le ultime, tragiche storie, in fondo è il Fato.
Emissario finale delle follie degli uomini, il Caso costringe i personaggi del romanzo di Salvati a mettere in gioco le uniche cose essenziali della vita – se stessi, a volte una moglie, un marito, i figli – per salvare la vita dalla morte ottenendo però in cambio probabilmente ancora la morte.
Una scommessa spietata e sincera, concitata e confusa, a carte sparse sul tavolo, resa urgente e frettolosa da una canna puntata che può esplodere solo due proiettili: la salvezza, ma più probabilmente la fine.
Le possibilità della paura sono lineari, stanno su una retta come le cose elementari ed originarie della geometria, partono da un punto che (ri)guarda una decisione, e spingono ai lati opposti; la paura o vince o perde, o vive o muore. E sul Pentcho diventa addirittura qualcosa che si annusa.
(“C’è poi la fragranza della paura. Un’essenza strana, diversa da persona a persona: a volte acida, altre dolciastra e rugginosa. Sempre, però, pronta a spandersi, tutte le volte in cui abbiamo creduto che fosse arrivato il momento di incontrare il nostro destino”: Rosalia Spiegel, poetessa e studentessa).
Ed è sulla retta della paura che altri costruiscono figure catastrofiche, rubandone un tratto, un segmento: c’è chi la paura la usa per pre-valere, abusare, pre-varicare, generare odio.
E la storia del Pentcho, qualunque sia il suo destino (“l’ottimismo, poi la delusione. La terra promessa, poi il deserto”, Ignatz Mittlemann, meccanico), a un certo punto apre braccia, diventa gambe, poi cuore e anche stomaco, con le parole che, come i numeri naturali si srotolano su una retta, individuano, punto per punto, i segni della priv-azione, della rabbia, del rifiuto, ma anche della poesia, del per-dono, della felicità (‘Deboli e fragili come siamo, per noi uomini il vero miracolo è la quieta, stabile banalità di ogni giorno: la gioia dei gesti ripetuti, anche dei più semplici’ – ancora Rosalia Spiegel).
La fuga degli ebrei del Pentcho, nella storia e nel libro di Salvati, ha una fine ben precisa. Invece di arrivare in Palestina, attraversando mille peripezie arriveranno addirittura in Calabria, a Ferramonti, nel più grande campo di concentramento per ebrei stranieri in Italia. Ma, in fondo, questo conta meno di quello che è accaduto durante i duri giorni del viaggio.
È doloroso riflettere sul fatto che, per raccontare questo libro, avremmo potuto fare a meno di riferire l’itinerario della paura con le sue coordinate spaziali e geografiche: e questo, tanto è presente, attuale, tragicamente ripetitivo il succeder-si di queste parole gravi, strazianti, e non soltanto nella storia dei popoli, ma anche delle persone, dei singoli (“per questo, nei mesi passati sul Penctho posso dire di aver conosciuto l’umanità intera. Ho scoperto il volto e la voce di ogni possibile uomo su questa terra, ma senza quasi mai allontanarmi dalla misera cuccetta in cui dormivo (…) ma attenzione: tutti questi comportamenti non appartenevano a persone diverse. Era dentro ognuno di noi che vivevano, per saltare fuori all’improvviso: senza nessun ordine, senza nessuna coerenza” (di nuovo Ignatz Mittelmann).
Resta da ultimo sullo sfondo un tragico, inquietante quesito.
Romanzi come il Pentcho, così potenti e spietati, diventando memoria condivisa servono davvero a curare il nostro presente oppure sono a ben vedere inutili?
Non sarebbe meglio lasciare queste parole nell’oblio, nel silenzio, escludendo di premiarle con l’immortalità, spegnendone i connotati, che erano riemersi, dalle nostre bocche nella forma di bocche?
Salvati non ha paura di questa domanda, e anzi la disegna sulle labbra di uno dei personaggi più riusciti, una giovane avvocatessa delusa dalla legge, dal diritto e dai suoi simili (“non merita di essere ricordata, l’atroce disillusione che ha cancellato l’unica sua certezza, quella forza che l’aveva sorretta in tanti, duri anni di studi: la fiducia nella legge […] non va raccontato, come il viaggio sul Pentcho abbia svelato a quella giovane entusiasta che, al contrario, proprio la legge spesso non è altro che lo strumento per giustificarli, quegli istinti: per assecondarli, dare loro libero sfogo, rendendoli rispettabili. Che diritto e giustizia non sono la stessa cosa, come credeva quando per la prima volta ha indossato la toga in tribunale, tra falsi attestati di stima e battute volgari pronunciate alle sue spalle, a mezza bocca: una intrusa, in un universo popolato solo da uomini sorpresi e infastiditi della sua presenza” (Julia Kustlinger Presser).
L’autore sembra non dare risposta a questa angosciosa domanda, ma secondo me quel che pensa, quel che sente, si può cogliere altrove: nel suo amore che emerge potente per le parole belle, quelle che vengono dichiarate, la retorica tacciata di buonismo che non teme giudizio.
Lettere care e docili strette dentro un fiocco rosso su capelli biondi che svolazzano tra sagome grigie, come un aquilone colorato su una spiaggia inquinata, che ridanno speranza a chi legge.
Sono queste parole belle che muovono al sorriso, ancora e ancora, come ritrova respiro un bosco violentato dalle fiamme, o come nasce una vita tra le doglie di un popolo violentato.
Parole giuste che fanno giustizia, se ripetute con coraggio: anche se ci fa sembrare stupide e stupidi, fallite e falliti. Perché magari ci convincono, prima o poi.
“Perché se è vero, come recita il detto, che nel gesto di condividere il pane siede l’angelo, nel dividere addirittura lo spazio, l’aria, il respiro come noi avevamo deciso di fare, c’era Dio”. (fo)
PENTCHCO
di Antonio Salvati
Editore Castelvecchi, ISBN 9788832903638
Editore Castelvecchi, ISBN 9788832903638