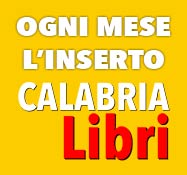di ELISABETTA BARBUTO, SANDRO FULLONE e DOMENICO MAZZA – Le nuove politiche infrastrutturali europee, ormai da qualche decennio, prediligono la realizzazione di opere fruibili per lotti funzionali. La richiamata nomenclatura è utilizzata per consentire l’uso di segmenti delle opere pensate, sin dal momento del collaudo dei tronchi e ancor prima che l’intera infrastruttura sia completamente realizzata. Per permettere ciò, ogni tratta dell’opera deve essere adeguatamente interconnessa e collettata a infrastrutture esistenti e operative.
Tali metodologie rappresentano le linee d’indirizzo che si stanno utilizzando per una serie di opere ferro-stradali attualmente in cantiere. Il terzo megalotto della statale 106 così come il lotto Battipaglia-Romagnano della nuova AV SA-RC, sono esempi plastici di quanto precedentemente esposto. Pur inquadrandosi, le richiamate opere, nei più ampi progetti di ammodernamento della dorsale stradale TA-RC e della direttrice ferroviaria tra SA e RC, saranno pienamente operative, nelle tratte sottoposte a intervento, già nei prossimi anni. L’illustrato dovrebbe invogliare le classi dirigenti locali a sviluppare idee che possano concorrere efficacemente a risollevare i territori dal baratro dell’isolamento geografico, suggerendo e adottando la messa a terra di opere che nel medio lungo periodo favoriscano la connessione per segmenti funzionali.
Lungo l’Arco Jonico, tuttavia, a percorsi di ricucitura e rigenerazione delle infrastrutture esistenti, si preferisce dedicare forze ed energie nella sponsorizzazione di opere dalla dubbia funzionalità. Vieppiù, adottando terminologie geograficamente inappropriate e figurativamente inadeguate per giustificare gli investimenti. A tal proposito, si prospettano cloni di aviosuperfici nella Sibaritide, immaginando improbabili bacini di riferimento e inquadrando come istmo una fra le più grandi pianure del Mezzogiorno d’Italia. Infrastrutture e definizioni geografiche che, evidentemente, esistono solo nella mente di chi le pensa.
La Politica deve studiare il territorio in cui opera. Basta alla povertà delle idee e ai linguaggi infarciti di slogan
Gli Establishment, a ogni livello di stratificazione, dovrebbero comprendere, prima di qualunque altra cosa, che per rappresentare, amministrare e gestire un territorio, quel territorio andrebbe studiato. La conoscenza di un ambito, d’altronde, non può essere certamente circoscritta al perimetro del Comune di residenza, al confine intermunicipale o al semplicistico concetto di limite provinciale. Sono tante le variabili che determinano l’appellativo di “territorio” a un determinato ambiente geografico. Si potrebbe partire dalla demografia, dalle omogeneità d’ambito, dai processi economici comuni, dalle condivise difficoltà a emergere e contribuire, sinergicamente, alla crescita della Regione di riferimento e del Paese tutto. Senza avere percezione di quanto in precedenza riportato, l’utilizzo del termine territorio, per definire un quadrante geografico, appare assolutamente fuori luogo e privo del benché minimo senso logico nell’affermazione. Tuttavia, ahinoi, è quanto sta accadendo lungo la sponda jonica sibarita. In quest’ambito, infatti, a visioni di crescita e prospettiva nel campo dei trasporti, della mobilità e della intermodalità, si preferiscono visioni megalomani e del tutto scollate dalla realtà effettuale. Non è pensabile, invero, che si continui a propagandare un nuovo scalo a Sibari, sapendo della grave emorragia demografica che attanaglia il territorio jonico e in generale la Calabria tutta. Parimenti, è del tutto anacronistico pensare a un quarto aeroporto in Calabria, quando Regioni demograficamente molto più dimensionate della nostra gestiscono i propri bisogni di mobilità (commerciali e civili) con la metà degli scali aerei. È da imprudenti definire l’area di Sibari come “istmo”, atteso che anche un bambino, con basi poco solide in geografia, capirebbe che una fra le principali pianure del Mezzogiorno di certo non può essere appellata come lingua di terra adagiata tra due mari. Non a caso, l’unico istmo d’Italia è lo stretto corridoio che si estende fra Catanzaro e Lamezia, bagnato dallo Jonio e dal Tirreno. Pertanto, se davvero si volesse connotare l’area di Sibari come raccordo e potenziale deviatoio dei flussi, bisognerebbe comprendere che l’ambito di maggior peso, in termini demografici, arriva da sud-est e non già da altri immaginati e improbabili quadranti cardinali.
È nella direttrice Sibari-Crotone che si nasconde il possibile potenziale dell’area, e non da altre parti. Se iniziamo a inquadrare Sibari come frontiera e non già come deviatoio alle diramazioni adriatica e tirrenica, non facciamo altro che favorire il gioco del centralismo storico. Non è un caso, infatti che, storicamente, giunti a Sibari, i flussi ferro-carrabili siano stati instradati verso l’area valliva della Calabria. Ambito, quest’ultimo, in cui le geometrie centraliste si annidano da tempo immemore. Tale sciagurato disegno ha generato la morte di Corigliano-Rossano e l’ecatombe per Crotone. Se davvero si volessero favorire i processi di crescita territoriale, bisognerebbe capire che è dall’asse Sibari-Crotone che si dovrebbe partire e non da altro. Perché è nel segmento Sibari-Crotone che il macrocontesto del Golfo di Taranto ha il suo anello debole. Dovrebbe essere, quindi, dirimente per tutta la Politica studiare soluzioni funzionali a rammagliare tutto il tessuto infrastrutturale della dorsale interregionale est compresa tra Ta-Metaponto-Sibari-Kr. E, certamente, ciò di cui il l’ambito non ha alcuna necessità è un nuovo scalo aereo. Se non altro perché dispone già di due scali (Taranto e Crotone) che necessitano di essere funzionalmente collegati al resto del contesto.
Pianificare opere di rigenerazione strutturale e upgrading tecnologico lungo la dorsale ferro-stradale KR-Sibari-Metaponto-TA
Le scelte relative al futuro tracciato della linea AV SA-RC hanno chiarito che non si prospettano cantieri imminenti in Calabria. Riteniamo inutile, pertanto, se non solo a fini strumentali, riservare attenzioni esclusivamente alle future vicende di tracciato della nuova AV, perdendo di vista il dibattito sui necessari lavori di upgrading lungo la ferrovia jonica. Parimenti, la predisposizione dei lavori di ammodernamento della statale 106 tra Sibari e Corigliano-Rossano e tra Crotone e Catanzaro, non possono rappresentare il raggiungimento di un risultato concreto. Un territorio potrà definirsi tale solo quando avrà la consapevolezza di essere tessera fondamentale e insostituibile di un più ampio mosaico geografico. Diventa, invero, fondamentale pensare a interventi che, nell’immediato futuro, possano permettere all’area dell’Arco Jonico di immaginare un domani. E non sarà certo la semplice elettrificazione del tronco Sibari-Crotone-Lamezia a disegnare un avvenire di sviluppo sostenibile per l’ambiente in questione. Abbiamo la certezza che entro il 2026 la velocizzazione AVR (alta velocità di rete fino a 200km/h) raggiungerà lo Jonio sulla sponda lucana. Dovrebbe essere un imperativo, quindi, per la politica nostrana, studiare sistemi che facilitino il percorso da e per Crotone-Sibari-Metaponto.
La riconnessione della dorsale a sud di Metaponto, pertanto, diventa funzionale per consentire all’Arco Jonico calabrese di avere un primo accesso alla AV già dal 2026. I lavori di miglioria lungo il tracciato compreso tra Metaponto e Battipaglia e le speranze riposte nella variante Tito-Auletta, permetteranno al Metapontino di raggiungere la Capitale in un tempo stimato di circa 3,5H. Sarebbe necessario, altresì, predisporre l’innalzamento a rango C della tratta Sibari-Metaponto. Quest’ultima, infatti, nonostante sia elettrificata già da circa 40 anni, risulta ancora non adeguata a rango C, pertanto inibita al transito dei treni veloci. Una sua elevazione strutturale, con l’aggiunta di un deviatoio nei pressi di Scanzano Jonico, consentirebbe ai treni provenienti dal Capoluogo pitagorico di raggiungere Roma in meno di 5 ore. Nella pianificazione del Por (’21-’27), è stata prevista la spesa di 32 miliardi da destinare al sud Italia. Una cifra mai vista prima e le cui modalità di assegnazione seguono le medesime prerogative dei fondi di Recovery.
Le prelazioni, dunque, dovrebbero favorire i territori rimasti indietro rispetto al Sistema Italia e, come dichiarato dal Ministero alle infrastrutture, particolare riguardo dovrà essere riservato alle opere ferroviarie. Sarebbe opportuno, quindi, lavorare a una riconnessione dei porti di Crotone e Corigliano-Rossano alla strada ferrata e, contestualmente, alla già prevista variante a sud di Crotone (a oggi sparita dai radar) verso lo scalo aeroportuale di Sant’Anna. Ancora, alla possibile fermata per la nota località turistica di Le Castella e alla nuova stazione baricentrica a servizio della futura area direzionale di Corigliano-Rossano. Senza dimenticare, la rettifica di tracciato a sud dell’abitato di Torre Melissa. Soprattutto, bisognerebbe smetterla di farsi abbindolare da RFI che vorrebbe barattare un progetto di innalzamento degli standard della mobilità d’ambito come la Bretella di Thurio, per una più modesta e poco funzionale Lunetta di Sibari. Ecco, gli interventi descritti rappresentano il minimo sindacale per cui una politica attenta, e non affascinata dall’effimero, dovrebbe impegnarsi. La velocizzazione del percorso verso Metaponto-TA, oltretutto, avrebbe un duplice vantaggio: avvicinerebbe temporalmente l’Arco Jonico calabrese al ramo AV Sa-Ta e rilancerebbe la direttrice verso l’Adriatico, oggi sconnessa dalla jonica. Non abbiamo più scuse, quindi, per continuare a cincischiare del nulla mescolato al niente. L’invito, pertanto, alle classi dirigenti della Sibaritide e del Crotonese affinché si rispetti una temporalità nelle azioni da perseguire. Senza, necessariamente, strumentalizzare argomenti al solo fine di scrivere qualcosa per dimostrare la loro esistenza ai rispettivi Popoli.
(Rispettivamente già parlamentare, già Amministratore e presidente del Comitato Magna Graecia)