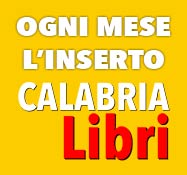di ANTONIETTA MARIA STRATI – È una stagione ricca di contrasti, quella che sta vivendo il Sud. Se da una parte cresce come non mai l’occupazione, dall’altra è inesorabile l’esodo dei giovani che svuota il Mezzogiorno di competenze e futuro. È questo il quadro emerso dal Rapporto Svimez, presentato a Roma dal direttore Luca Bianchi.
Tra il 2021 e il 2024, quasi mezzo milione di posti di lavoro è stato creato nel Mezzogiorno, spinto da PNRR e investimenti pubblici. Ma negli stessi anni 175 mila giovani lasciano il Sud in cerca di opportunità. La “trappola del capitale umano” si rinnova: la metà di chi parte è laureato; le migrazioni dei laureati comportano per il Mezzogiorno una perdita secca di quasi 8 miliardi di euro l’anno. I giovani che restano, troppo spesso, trovano lavori poco qualificati e mal retribuiti. Con i salari reali che calano aumentano i lavoratori poveri: un milione e duecentomila lavoratori meridionali, la metà dei lavoratori poveri italiani, è sotto la soglia della dignità. Si evidenzia, inoltre, una emergenza sociale nel diritto alla casa.
Il PNRR sostiene la crescita e spinge fino al 2026 il Pil del Sud oltre quello del Nord. Il percorso di sviluppo avviato dal PNRR non può interrompersi nel 2026. Il Mezzogiorno sta dimostrando di poter essere protagonista della transizione industriale ed energetica del Paese, ma servono scelte politiche forti per consolidare i risultati raggiunti e dare continuità agli investimenti. Tra i segnali positivi nel Mezzogiorno sui quali costruire il futuro post PNRR: la crescita dei servizi ICT, la crescita dell’industria, il miglioramento dell’attrattività delle università meridionali. Ma la legacy del PNRR riguarda anche cambiamenti sociali e istituzionali che devono orientare il complesso delle politiche pubbliche: il miglioramento della capacità amministrativa dei Comuni; i primi segnali di convergenza Sud-Nord nell’offerta pubblica di asili nido e del servizio mensa nelle scuole; la standardizzazione e semplificazione degli iter amministrativi.
Per la Svimez, dunque, la vera sfida «è consolidare questi segnali positivi in un percorso di sviluppo duraturo, che renda il diritto a restare pienamente esercitabile e la decisione di partire una scelta, non una necessità. Occorre agire su quattro leve: potenziare le infrastrutture sociali e garantire i servizi oltre il Pnrr; rafforzare i settori a domanda di lavoro qualificata; puntare sulla partecipazione femminile nel mercato del lavoro, nel sistema della ricerca e nella sfera politica e decisionale, dove rivestono un peso ancora marginale; investire sul sistema universitario come infrastruttura di innovazione».
È lo stesso Bianchi a ribadire come «il Mezzogiorno sta crescendo in questi ultimi anni grazie al PNRR. Ora la sfida è dare continuità a questo ciclo d’investimenti».
A fargli eco il presidente Adriano Giannola, evidenziando come «grazie al Pnrr persistenti segnali di ripresa dell’economia e del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno che, tuttavia, non riescono a incidere e prevalere sulle dinamiche migratorie e sulle prospettive di vita delle giovani generazioni. Si conferma infatti che tanti giovani scelgono le Università del Nord soprattutto perché offrono qualificate prospettive di opportunità di lavoro anche, e sempre più, fuori Italia».
I dati del Rapporto, infatti, ci dicono come tra 2021 e 2024 il Pil del Mezzogiorno aumenta dell’8,5%, contro +5,8% del Centro-Nord. A determinare questo scarto contribuiscono diversi fattori: la minore esposizione dell’industria meridionale agli shock globali; un ciclo dell’edilizia particolarmente favorevole legato prima al maggiore impatto espansivo degli incentivi edilizi, poi allo stimolo fornito dal Pnrr la chiusura del ciclo 2014-2020 della politica di coesione. A ciò si è aggiunta la ripresa del turismo e dei servizi, che ha rafforzato la domanda interna. E ancora: le costruzioni sono il motore principale: +32% nel Sud contro +24% nel Centro-Nord. Per il peso che riveste nella formazione del valore aggiunto dell’area, il contributo più rilevante alla crescita del Pil 2021-2024 del Mezzogiorno è venuto dal terziario: +7,4% l’aumento medio in Italia dei servizi, che raggiunge il +7,8% nel Mezzogiorno (+7,3% nel Centro-Nord). La crescita non si è limitata ai servizi tradizionali. Crescono le attività finanziarie, immobiliari, professionali e scientifiche che hanno goduto degli effetti di domanda di nuova progettualità pubblica e privata attivata dal Pnrr.
Nel biennio 2023-2024 l’effetto espansivo del Pnrr che è valutabile in circa 0,9 punti di Pil nel Centro-Nord e 1,1 punti nel Mezzogiorno. Gli investimenti attivati dal Piano hanno di fatto scongiurato il rischio di una stagnazione della crescita italiana.
Secondo le stime Svimez, l’Italia crescerà poco ma in miglioramento: +0,5% nel 2025, +0,7% nel 2026, +0,8% nel 2027. Grazie al completamento dei cantieri PNRR, il Sud dovrebbe continuare a superare il Centro-Nord nel biennio 2025-2026: +0,7% e +0,9%, contro +0,5% e +0,6% del Centro-Nord. Complessivamente, sulla crescita cumulata del biennio 2025-2026, la domanda di investimenti pubblici dovrebbe valere 1,7 punti di Pil nel Mezzogiorno e 0,7 punti nel Centro-Nord. Nel 2027 rallenta ciclo investimenti pubblici, riparte la domanda internazionale e il Centro-Nord torna a crescere più del Sud (+0,9% contro +0,6%).
Per il direttore Bianchi «ora la sfida è dare continuità a questo ciclo d’investimenti. Bisogna migliorare la spesa delle politiche di coesione e ricostruire un quadro di politica industriale che valorizzi la grande impresa del Mezzogiorno e i tanti settori che stanno vincendo la sfida della competitività», mentre il presidente Giannola punta l’attenzione sui giovani, evidenziando «come l’emorragia di giovani italiani altamente formati investe anche il Centro-Nord che, pur perdendo capitale umano a vantaggio di poli stranieri, lo recupera ancora grazie alle migrazioni interne dal Sud. Al Mezzogiorno, quest’emigrazione qualificata infligge una perdita secca e impone una drastica segregazione ai giovani meno “ricchi e formati” che rimangono e alimentano il boom dell’occupazione soprattutto nel terziario dei servizi a basso valore aggiunto e precario; al contempo l’industria manifatturiera ristagna o perde colpi. Per trattenere le competenze nelle regioni meridionali e uscire dalla trappola dei bassi salari e del lavoro povero la priorità è garantire la qualità dell’occupazione e delle retribuzioni. Se è vero che nel periodo 2021-2024 il Sud cresce più del Centro-Nord, è altrettanto vero che in quegli anni contiamo ben 100mila poveri in più nel Mezzogiorno».
Dal Rapporto Svimez, infatti, emerge come «tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell’occupazione pari all’8%, contribuendo per oltre un terzo al milione e quattrocentomila nuovi occupati a livello nazionale. Il Centro-Nord ha aggiunto circa 900mila posti, il Sud quasi 500mila. Le politiche pubbliche hanno svolto un ruolo determinante: prima l’espansione degli incentivi edilizi, poi l’avvio dei cantieri Pnrr e l’aumento degli organici nella pubblica amministrazione hanno sostenuto occupazione in edilizia, servizi professionali e filiere manifatturiere legate agli investimenti pubblici».
Cresce l’occupazione giovanile, soprattutto nel Mezzogiorno. Nel triennio 2021-2024 gli under 35 occupati sono aumentati di 461mila unità a livello nazionale, di cui 100mila nel Sud. Il tasso di occupazione giovanile cresce più al Sud (+6,4 punti), ma resta molto più basso rispetto al Centro-Nord (51,3% contro 77,7%).
Nonostante il boom occupazionale, il Mezzogiorno non trattiene i giovani. Tra i due trienni 2017-2019 e 2022-2024 le migrazioni dei 25-34enni italiani sono aumentate del 10%: nell’ultimo triennio 135mila giovani hanno lasciato l’Italia e 175mila hanno lasciato il Sud per il Nord e l’estero. Un paradosso evidente: più lavoro ma non migliori condizioni di vita, né opportunità professionali adeguate alle competenze.
La conseguenza è che il Sud forma competenze che alimentano la crescita e l’innovazione altrove. I dati dicono che sono oltre 40mila i giovani meridionali che si trasferiscono ogni anno al Centro-Nord, mentre 37mila laureati italiani emigrano all’estero. Con l’emigrazione di questi laureati, una parte del rendimento potenziale dell’investimento pubblico sostenuto per la loro formazione viene dispersa. Il bilancio economico di questo movimento è pesante: dal 2000 al 2024 il Mezzogiorno perde di investimenti 132 miliardi di euro di capitale umano, contro un saldo positivo di 80 miliardi per il Centro-Nord. Poli esteri che attraggono giovani italiani altamente formati, il Centro-Nord che perde verso l’estero ma recupera grazie alle migrazioni interne di laureati da Sud, il Mezzogiorno che li forma e continua a perderli.
Nel Mezzogiorno, nel 2021-2024, sei nuovi occupati under35 su dieci sono laureati, contro meno di cinque nel resto del Paese. Tuttavia, la prima porta d’ingresso al lavoro rimane il turismo: oltre un terzo dei nuovi addetti giovani si colloca nella ristorazione e nell’accoglienza, settori a bassa specializzazione e bassa remunerazione. Al tempo stesso, crescono i giovani laureati nei servizi ICT e nella pubblica amministrazione, grazie al PNRR e alla riforma degli organici pubblici. La qualità delle opportunità resta però insufficiente: il mercato del lavoro meridionale continua a offrire sbocchi concentrati nei comparti tradizionali, con scarsa domanda di competenze avanzate.
Per trattenere i giovani, il Sud deve attivare filiere produttive ad alta intensità di conoscenza, rafforzare la base industriale innovativa e integrare formazione superiore, ricerca e politiche industriali. Senza un salto di qualità nella domanda di competenze, la mobilità giovanile continuerà a essere una scelta obbligata.
Un altro dato rilevato dalla Svimez sono i salari, che sono in calo, soprattutto nel Mezzogiorno: Dal 2021 al 2025 i salari reali italiani hanno perso potere d’acquisto, con una caduta più forte nel Sud: -10,2% contro -8,2% nel Centro-Nord. Inflazione più intensa e retribuzioni nominali più stagnanti accentuano il divario.
In Italia i lavoratori poveri sono 2,4 milioni, di cui 1,2 milioni al Sud. Tra il 2023 e il 2024 aumenta il numero dei lavoratori poveri: +120mila in Italia, +60mila al Sud. Non basta avere un’occupazione per uscire dalla povertà: bassi salari, contratti temporanei, part-time involontario e famiglie con pochi percettori ampliano la vulnerabilità.
Nel 2024 le famiglie povere crescono nel Mezzogiorno dal 10,2% al 10,5%. Centomila persone in più scivolano nella povertà assoluta, per effetto di un aumento delle famiglie che risultano in povertà assoluta anche se con persona di riferimento occupata.
Sono i Comuni ad aver dato lo stimolo più forte agli investimenti pubblici: raddoppiati nel Mezzogiorno tra il 2022 e il 2025 da 4,2 a 8 miliardi di euro. Oltre che alla maggiore flessibilità introdotta con la modifica del Patto di stabilità, tale dinamica va ascritta principalmente alla soddisfacente capacità dei Comuni nell’attuare le misure del Pnrr.
Il Pnrr destina 27 miliardi di opere pubbliche al Sud. Tre cantieri su quattro sono in fase esecutiva al Sud, in linea con il dato del Centro-Nord. Il 25% dei progetti al Centro-Nord è già alla fase del collaudo; il 16,2% al Mezzogiorno.
La Svimez, in collaborazione con l’Ance, ha realizzato un monitoraggio aggiornato a fine ottobre 2025 sullo stato di avanzamento dei cantieri delle infrastrutture sociali finanziate dal PNRR: interventi per un valore complessivo di circa 17 miliardi di euro affidati in larga parte a Comuni e Regioni per la realizzazione di opere nei servizi per la prima infanzia, nell’edilizia scolastica e nella sanità territoriale. Nel Mezzogiorno i cantieri PNRR per infrastrutture sociali dei Comuni sono in fase avanzata progetti per il 51,5% del valore complessivo delle risorse contro solo il 33% di quelli delle Regioni.
Le attività di assistenza tecnica offerta dai centri di competenza nazionale alle amministrazioni locali responsabili degli interventi ha consentito l’accelerazione e standardizzazione degli iter amministrativi. Con il Pnrr si sono ridotti i tempi medi di progettazione delle opere rispetto al pre Pnrr con una sostanziale convergenza Sud/Nord: nel Mezzogiorno da 20,4 a 7,1 mesi; nel Centro-Nord da 16,8 a 7,4.
«Grazie agli investimenti del Pnrr – scrive la Svimez – i Comuni del Mezzogiorno stanno realizzando un miglioramento nei servizi educativi per l’infanzia e per la scuola. I primi risultati sono già visibili: crescono i posti negli asili nido pubblici e aumenta la quota di alunni che frequentano scuole dotate di mensa, due indicatori fondamentali del diritto di cittadinanza all’istruzione».
Per Giannola «a conti fatti, il contributo decisivo alla crescita meridionale è venuto dall’edilizia, sostenuta in una prima fase dagli incentivi del vituperato – malgovernato Superbonus, poi dagli investimenti pubblici legati al PNRR, al quale hanno dato una spinta importante tra il 2022 e il 2025 gli investimenti dei Comuni, che sono raddoppiati. Come suggeriscono le nostre previsioni, il Sud continuerà a crescere più del Nord finché c’è il PNRR: alla fine di questo vero e proprio “intervento straordinario dell’Europa” che accadrà?».
S«e non è errato dire che le risorse del Pnrr – ha proseguito il presidente della Svimez – hanno prevalentemente mirato alla revisione e manutenzione di un sistema che non cresce da troppi anni, si conferma l’aspettativa che riprenda il deludente tratto delle Politiche di Coesione».
«Ma fare sviluppo – ha evidenziato – vuol dire cambiare, non limitarsi a “tenere assieme i pezzi”. Una valutazione che non riguarda solo il Sud, ma anche per molti versi il Centro-Nord, quindi l’intero Paese. Non a caso la Commissione Europea diagnostica l’Italia prigioniera nella “trappola dello sviluppo”. Eppure, avremmo potenzialità che non sfruttiamo adeguatamente, sintetizzabili in primis nella posizione privilegiata nel Mediterraneo, che offre vantaggi comparati per realizzare la “doppia transizione” programmata dalla UE».
«Mettere in campo sistematicamente e non per caso – ha concluso – tra le celebrate energie rinnovabili, la risorsa geotermica contribuirebbe e non poco alla nostra autonomia nella transizione energetica. Per le aree meridionali, che ne hanno in abbondanza, sarebbe un potenziale complemento alle mai avviate Autostrade del Mare, essenziali per realizzare la “Logistica a valore”, articolata in porti e retroporti attrezzati e favoriti dai privilegi fiscali delle Zone Doganali Intercluse».
Per la Svimez, poi, l’avvio delle pre-intese sull’autonomia differenziata può compromettere l’efficacia degli interventi del Pnrr: se da una parte c’è il Piano nato per ridurre i divari territoriali migliorare i servizi essenziali e rafforzare la capacità amministrativa delle aree più fragili, soprattutto nel Mezzogiorno, dall’altra c’è una riforma che rischia di aumentare le diseguaglianze, sottraendo risorse e competenze condivise e frammentando i diritti di cittadinanza.
Il risultato è una riforma nata per ricucire il Paese si sovrappone a un’altra che può accentuarne le fratture. Senza un quadro unitario, gli effetti positivi del PNRR rischiano di indebolirsi proprio ora che stanno emergendo. La contraddizione è ancora più evidente perché il Pnrr include tra le sue riforme la revisione organica del federalismo fiscale, pensata per garantire livelli essenziali delle prestazioni uniformi e ridurre i divari. L’autonomia differenziata va nella direzione opposta e rischia di compromettere l’efficacia stessa del Piano.
Il Mezzogiorno continua a presentare un marcato divario infrastrutturale rispetto al Centro-Nord. Ed anche gli indici di accessibilità alle infrastrutture esistenti mostrano come, a fronte di valori medi superiori nelle regioni settentrionali per strade e ferrovie, le regioni meridionali si fermano spesso intorno o al di sotto, con punte molto basse nelle città minori, con ritardi più profondi al Sud nel caso delle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità, dei servizi sanitari e della rete impiantistica per la gestione dei rifiuti. Posto uguale a 100 l’indice medio di accessibilità Italia per le infrastrutture ospedaliere, il Mezzogiorno registra un valore pari ad appena 68 contro il 132 del Nord e il 118 del Centro.
La Svimez, poi, ha ribadito come il rilancio del Mezzogiorno passa dalle grande aziende. Nonostante il loro peso sia ancora limitato, è significativo: quasi 600mila addetti e 46 miliardi di valore aggiunto, concentrati in pochi poli industriali. Nei comparti a più elevata tecnologia l’incidenza occupazionale dei grandi impianti al Sud supera il 50% (30% nelle altre aree).
Tra i tanti dati, emerge, infine, come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Italia resta tra le più basse d’Europa, nonostante i segnali positivi registrati tra il 2021 e il 2024. Il tasso di occupazione femminile, pur in crescita, è ancora lontano dagli standard europei e presenta forti divari tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Persistono inoltre fenomeni strutturali di segregazione e precarietà: nel Sud le donne lavorano soprattutto in settori a bassa remunerazione e produttività, con contratti spesso temporanei o part-time involontari. A pesare sono anche le limitate opportunità di carriera, frenate da barriere culturali e dalla mancanza di adeguate politiche di conciliazione. Ne derivano ampi divari retributivi e una partecipazione femminile molto diseguale, soprattutto nelle aree più deboli per struttura produttiva e servizi di welfare. (ams)